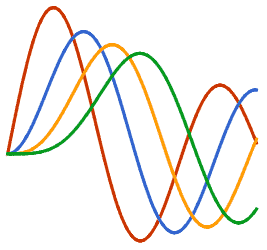- Redazione P&D - 08/06/2009
ART. 2103 C.C. E DEQUALIFICAZIONE LECITA – Rocchina STAIANO
L'art. 2103 c.c., dopo avere nel primo comma vietato l'assegnazione del lavoratore a mansioni inferiori a quelle per cui è stato assunto, stabilisce nel secondo comma che "ogni patto contrario è nullo".
Si disputa, in dottrina e in giurisprudenza se questa norma debba valere anche quando il patto contrario venga stipulato nell'interesse del lavoratore e, più precisamente, quando esso serva ad evitare il licenziamento, o per infermità del lavoratore o per esigenze tecniche, organizzative o produttive.
Un orientamento giurisprudenziale delineatosi per primo si esprimeva in senso positivo, ossia nel senso della assoluta inderogabilità della norma, nel presupposto che una poco libera o comunque errata valutazione dei propri interessi da parte del lavoratore, eventualmente privo delle conoscenze tecnico giuridiche necessarie alla consapevole autodeterminazione oppure suggestionato da pessimistiche prospettazioni, avrebbe potuto indurlo ad un sacrificio non libero del proprio patrimonio professionale, tutelato anche a livello costituzionale (art. 35, secondo comma, Cost.). Ad evitare la definitiva perdita del posto di lavoro sarebbe stato necessario, secondo questa tesi, un licenziamento seguito da riassunzione con mansioni inferiori, vale a dire la rinnovazione del contratto di lavoro, e sempreché nella vicenda negoziale non dovesse ravvisarsi una frode alla legge, ossia l'elusione dell'art. 2103 c.c. (Cass. 14 gennaio 1985 n. 37, 5 aprile 1985 n. 2231, 18 giugno 1987 n. 5388, 23 gennaio 1988 n. 539 e, sull'eventuale frode alla legge, cfr. Cass. 17 aprile 1996 n. 3640).
L'altro e più recente orientamento ritiene che il divieto contenuto nel capoverso dell'art. 2103, giustificato nella sua rigidità quando lo stesso articolo venne novellato dall'art. 13 l. n. 300 del 1970 ossia in una situazione generalmente favorevole del mercato del lavoro, debba oggi essere interpretato nel senso che sulla tutela della professionalità debba prevalere quella dell'interesse al mantenimento del posto di lavoro (artt. 4 e 36 Cost.). Ne consegue la validità dei patti di dequalificazione intesi ad evitare il licenziamento (Cass. 7 marzo 1986 n. 1536, 4 maggio 1987 n. 4142, 23 novembre 1990 n. 11312, 20 maggio 1993 n. 5695), salva sempre la verifica della piena libertà del consenso prestato dal lavoratore (Cass. 2 novembre 1993 n. 10793).
Quest'ultimo costituisce dunque il limite invalicabile, anche alla stregua della giurisprudenza meno rigida, con la conseguente non configurabilità di un diritto potestativo, spettante all'imprenditore, di variare in peggio le mansioni del lavoratore, ancorché all'asserito scopo di avvantaggiarlo.
Quanto alla possibilità di prevedere variazioni in peggio della posizione professionale di singoli lavoratori attraverso un contratto collettivo, essa in via generale è da escludere poiché la posizione professionale del singolo non può essere stabilita che col contratto individuale, non derogabile se non in meglio dal contratto collettivo (art. 2077, secondo comma, cod. civ.). Restano salve le ipotesi di deroga legale a questa regola, come quella contenuta nell'art. 4, comma 11, l. 23 luglio 1991 n. 223, secondo cui "gli accordi sindacali stipulati nel corso delle procedure di cui al presente articolo (ossia le procedure per la cosiddetta dichiarazione di mobilità), che prevedano il riassorbimento totale o parziale dei lavoratori ritenuti eccedenti, possono stabilire, anche in deroga all'art. 2103 del codice civile, la loro assegnazione a mansioni diverse da quelle svolte".
Il consenso del lavoratore alla dequalificazione è dunque necessario anche quando essa serva alla riorganizzazione dell'azienda in modo da evitare o anche da ridurre il ricorso alla cassa integrazione guadagni (Cass. 29 novembre 1988 n. 6441).