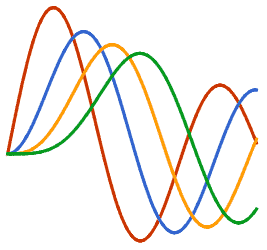- Redazione P&D - 23/10/2012
LAVORARE E VIVERE A TARANTO - Francesco CIANFALONI
La condizione degli operai dell"Ilva di Taranto è stata presentata come un caso classico di scelta tragica: lavorare e ammalarsi, forse morire; o rifiutare di ammalarsi, chiedere il risanamento e restare senza lavoro e senza soldi, o con quelli dell"assistenza pubblica. Le cose non stanno affatto così. Non stavano così quando l"impianto è stato costruito e avviato; non stanno così neppure ora. Non perché sia facile ricondurre l"inquinamento a livelli tollerabili e avviare la bonifica della città ma perché è possibile, e quindi necessario. Costoso ma possibile. Non si tratta di una opinione personale ma dei risultati delle analisi dei tecnici su cui è costruita la motivazione della sentenza del Tribunale del riesame del processo Ilva, pubblicata anche sull"ultimo numero di "Ambientelavoro".
Quanto sono costose la messa a norma dell"impianto e la bonifica della città? Oltre che possibili, sono anche probabili?
Non sono domande cui sia facile rispondere. Per una persona isolata la risposta è addirittura impossibile. Anche un isolato può fare però delle osservazioni preliminari.
Quella dell"acciaio è una produzione necessaria; non solo nel caso di un paese manifatturiero, come l"Italia, ma per qualsiasi paese che non faccia le case e i ponti solo di pietra, legno e mattoni. È anche una produzione costosa, perché usa impianti complessi, usa molta energia e genera sottoprodotti inquinanti ed estremamente pericolosi (diossina, benzopirene, furani, polveri sottili) che bisogna non disperdere ma contenere, raccogliere, rimuovere. Non è però una produzione necessariamente omicida come quella dell"Eternit. L"amianto, bianco o blu che sia, è cancerogeno di per sé. È rischioso estrarlo, maneggiarlo, trasportarlo, lavorarlo, usarlo come isolante o per produrre un materiale solido resistente e impermeabile per le coperture, come l"Eternit. Il rischio è permanente durante la produzione e durante l"uso, per sempre. L"amianto va lasciato in pace dove si trova; non va frequentato proprio. L"acciaio può essere usato in modi pessimi, ma non è pericoloso di per sé e può essere molto utile.
La motivazione della sentenza è estremamente importante perché, oltre a dimostrare che l"inquinamento della città e dell"impianto e il danno evitabile ai cittadini e agli operai non è solo eredità della gestione Iri ma anche responsabilità della gestione Ilva, fino al 2006 e negli anni successivi, in violazione della sentenza del 2006, fornisce una serie di indicazioni sulle tecniche disponibili per ricondurre le emissioni nocive entro i limiti di legge. Per lo più le indicazioni sono tratte dal Best available techniques reference report for iron and steel del 2011.
La lettura, all"inizio, è confortante proprio perché si legge un lungo elenco di cose fattibili, articolato area per area, impianto per impianto. Si sostiene la colpevolezza dei proprietari e dei responsabili, su cui dovrà decidere il tribunale. Ma si indicano le cose da fare per rimediare. Alla lunga però il lettore è travolto dal numero, dalla entità, dal presumibile costo delle cose da fare. Se si apre il sito dell"Ilva si trovano confortanti elenchi di miglioramenti nelle misure degli inquinanti peggiori. Se si legge la motivazione si trova un impietoso elenco di luoghi in cui le misure non vengono fatte, o non vengono fatte in continua, come dovrebbero. Chiunque abbia avuto a che fare con impianti di questo genere – cementerie, acciaierie, anche semplici inceneritori – sa che non sono progettati per produrre diossina, o per intasarsi, per esplodere, per lasciar sfuggire polveri e gas. Ma qualche volta lo fanno. Perciò una rilevazione seria deve essere continua, e gestita o controllata da una autorità terza, perché non esiste in natura, o è molto raro, l"addetto che quando vede dal grafico delle temperature che per qualche ora dal camino è uscita diossina si precipiti alla Asl o in tribunale, a mettere nei guai l"azienda per cui lavora e se stesso.
Man mano che si va avanti nella lettura ci si rende conto che si sta descrivendo un impianto vecchio, che perde da tutte le parti, che non ha le attrezzature più elementari – aspiratori, impermeabilizzazioni, filtri adeguati – in cui perdono i portelli, le pareti stesse dei contenitori. Ci si chiede: come si è ridotto così un impianto modello, tra i maggiori in Europa, il maggiore in Italia, imitato o replicato in Corea e altrove?
Le origini, il percorso
Mi è accaduto di fare da giovane, più di mezzo secolo fa, l"ingegnere del petrolio, alle dipendenze dell"Agip, e di essere compagno di corso di qualcuno degli ingegneri assunti dall"Iri e mandati ad avviare l"impianto di Taranto, dopo un tirocinio a Cornigliano, a Bagnoli, sotto la direzione di ingegneri esperti provenienti da Terni, qualcuno dei quali, da pensionato, ha poi fatto da consulente in Corea. Ho visitato l"impianto nei primi anni sessanta, senza capire molto, ovviamente, ma vedendo e annusando; sentendo i rumori, gli stridori. Ho anche avuto amici a Taranto, allora, che avevano presenti i problemi ambientali e sociali della città: la difficile convivenza tra la città vecchia, dei pescatori, e quella nuova, dell"industria; la lunga serie di interventi esterni – la marina militare, il tubificio, l"acciaieria, la cementeria – che ne hanno fatto insieme una prospera città di immigrazione e uno dei luoghi più inquinati d"Italia. Ho sentito raccontare dagli ingegneri le difficoltà del rapporto tra i vecchi operai liguri, esperti e solidali, e i neoassunti, braccianti, contadini immigrati, che si adeguavano a fatica al nuovo ambiente, difficile, pericoloso. Ho sentito raccontare del rifiuto dei nuovi di darsi da fare per lo spegnimento di un grave incendio, consentito da un difetto originario di progettazione e provocato dall"inesperienza di un operaio, che metteva a repentaglio l"impianto e la vita stessa, perché non era affar loro. Grande scandalo, ovviamente, dei vecchi operai liguri e dei tecnici. Chi raccontava era sì ingegnere ma anche figlio di uno scaricatore del porto di Ancona. Difficile che deformasse per disprezzo del lavoro manuale o per antimeridionalismo.
In sostanza, allora, eravamo tutti consapevoli di quanto sia difficile la trasformazione di un ammasso di braccianti e manovali in classe operaia, solidale e democratica, attenta alla sicurezza propria e altrui, consapevole dei diritti, capace di produrre bene per sé e per gli altri. Ci vogliono organizzazione, idee che circolano, libertà, partecipazione. E devono volerlo, o consentirlo, per amore o per forza, anche i padroni. A Ivrea, dove il padrone era un soggetto attivo, voleva l"autonomia, la creatività, la solidarietà; in Emilia, dove le cooperative erano ancora vere e solidali; ma anche a Torino, a Milano, a Marghera, dove le cose sono state un po" più difficili e molto conflittuali, la trasformazione più o meno è avvenuta; il risultato è stato raggiunto. Non come nelle favole – e basti pensare ai conflitti tra operai e quadri, tra sindacalisti, della fine degli anni settanta – ma, almeno per l"ambiente, un poco sì. Poi le cose sono peggiorate anche dove almeno il controllo sulla nocività sembrava raggiunto. A Taranto, si direbbe, il processo non si è mai veramente avviato, a giudicare da quello che si vede dall"esterno.
Ma, allora, l"impegno dei tecnici era per costruire un impianto all"avanguardia: il primo interamente gestito da un calcolatore di processo, dalla gestione delle colate al numero delle passate delle bramme sotto i rulli dei laminatoi; il primo che pretendesse di pesare e titolare tutto ciò che entrava nei convertitori e tutto ciò che ne usciva, inclusi i fumi. Altro che portelli che perdono e misure fatte quando fa comodo! A leggere che con i rottami finiscono in forno anche olii e chissà cos"altro, perché non è garantita neppure l"apertura dei contenitori per vedere cosa c"è, viene da piangere. A guardarlo, a starci un po" in un giorno normale, l"impianto allora non sembrava inabitabile. Meglio di un cantiere di perforazione, con l"olio, il fango, le puzze; anche se un laminatoio non è esattamente silenzioso.
Solo chi a Taranto ci vive e conosce almeno qualcuno che ci lavora, qualcuno dei controllori, qualche sindacalista, può azzardare qualche interpretazione e qualche critica.
Dall"esterno si direbbe che tutto abbia proceduto per inerzia, come in tanti altri campi; come per la Fiat; come per Porto Marghera. Le decisioni prese per inerzia si sono accumulate: il raddoppio, i mancati rinnovamenti, il deterioramento dell"amministrazione della città. Certo l"Italsider negli anni prima della cessione all"Ilva di Riva non si sarà svenata in investimenti, come la Fiat prima della programmata vendita a General Motors. E Riva avrà fatto il minimo indispensabile per andare avanti con un impianto che, per la parte più vecchia, funziona da più di mezzo secolo. Il minimo dal punto di vista della uscita dei laminati, non da quello della salute degli operai e dei cittadini di Taranto, per non parlare della campagna e del mare. Un"acciaieria non deve rinnovare i modelli tutti gli anni o quasi, come dovrebbe una fabbrica di automobili, e come la Fiat non ha fatto, o come, ossessivamente, la moda. Ma c"è la qualità; ci sono gli acciai speciali; c"è la progettazione di impianti. A Udine Danieli, che progetta e produce impianti per acciai speciali, pare vada benissimo, ed è attivo anche in Svezia. L"Ilva, inquinamento a parte, è finito a fare ciò che fa la Cina, che però è un colosso: produce il 46% di tutto l"acciaio del mondo, più di 650 milioni di tonnellate. In questo campo il costo del lavoro non conta nulla; anche meno che nei montaggi finali dell"auto. Ma il dumping ecologico conta molto; e su questo terreno è difficile fare peggio dei cinesi, a giudicare da ciò che si legge.
Forse sono ancora accecato dagli entusiasmi industrialistici di mezzo secolo fa: il lavoro ben fatto, il controllo della produzione, il controllo dell"ambiente, l"istruzione, la ricerca. Ma negli ultimi trent"anni siamo stati tutti un po" accecati dall"idea della fine dell"industria, del passaggio ai servizi; forse della fine del lavoro.
La fabbrica come sistema sociale
Vedere una parte degli operai che scioperano contro i giudici che vogliono salvargli la vita, o le manifestazioni dei quadri a sostegno dei dirigenti che inquinano, è una sofferenza. Non è una gioia vedere che anche a Taranto, come quasi dappertutto, i giudici sono rimasti l"ultimo baluardo a difesa della vita di chi lavora o di chi vive vicino agli impianti. È bene che a giudicare i presunti omicidi volontari siano solo i giudici, non i cittadini. Ma a controllare l"inquinamento, i ritmi, lo stress, a prevenire la malattia e la morte di chi lavora, dovrebbero essere i lavoratori attivi e informati. I giudici possono intervenire, se la fabbrica come sistema sociale non li assiste, solo a cose fatte, quando i malati e i morti ci sono già, quando il sistema è sfuggito di mano.
Ha fatto piacere sentire Landini dichiarare che non si sciopera contro i giudici. Ma il disfacimento dei rapporti sociali interni agli stabilimenti è sotto gli occhi di tutti. Si legge con soddisfazione e speranza della tenuta, anche sociale, dei distretti, anche in emergenze gravi come il terremoto di Mirandola e Mantova.
Quello che manca è la reciproca comprensione tra l"iniziativa dal basso per i Gruppi di acquisto solidale, o per il risparmio energetico, e la ricerca, la politica, la produzione. Non è di grande soddisfazione sapere che abbiamo raggiunto gli obiettivi di energie rinnovabili, ma con incentivi eccessivi e comprando all"estero le pale per l"eolico e i pannelli solari. Siamo divisi tra iperrealisti che sostengono la marginalità delle energie rinnovabili, e sono stati rapidamente smentiti dai fatti (in Svezia sono al 44%), e puristi che pensano che ogni consumo di energia inquini.
Il minimo indispensabile
Ma la cosa che manca di più è la connessione con idee generali. Si oscilla tra la aspirazione a una società comunitaria e la accettazione di tutto, perché gli interessi costituiti non si toccano. Prima si sono costruiti gli impianti più inquinanti nell"Italia più povera, come le raffinerie a Porto Torres. Poi si prolungano all"infinito i sussidi, per umanità e soprattutto perché nessuno vuol perdere i voti in una regione che non ha altre risorse. Chissà se i minatori della Carbosulcis hanno votato per Cappellacci, che aveva promesso la luna?
Ho letto di recente che l"Italia ha aumentato l"esportazione di coke, che è una produzione molto inquinante, soprattutto se i forni perdono e il recupero dei gas non è adeguato. Non vorrei che, con la caduta del consumo di acciaio, l"Ilva, o chi per essa, si sia messa a importare carbone per esportare coke, che equivale a importare petrolio per esportare benzina, a cacciare Taranto nella posizione di Porto Torres.
L"esempio può essere sbagliato, per scarsa informazione, ma l"aumento delle esportazione di coke e prodotti raffinati è un dato Istat; e non è sbagliato in generale chiedere un coordinamento. I forni per la cokefazione sono tra gli impianti più inquinanti di Taranto. Se, per ipotesi, non dovessero produrre per le fusioni che si fanno lì accanto, sarebbe il momento giusto per chiuderne qualcuno e sostituirlo o metterlo a norma, non per esportare coke. È quello che spero facciano i commissari nominati dal tribunale. Mi rendo conto che un"impresa è padrona in casa sua e che si adegua al mercato come ritiene opportuno; ma finché non mi ammazza. Se viola la legge, la decisione passa al giudice.
Tratto da www.lostraniero.net