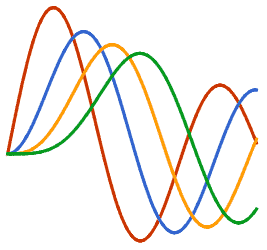- Mazzola Marcello Adriano - 14/10/2013
DIRITTI DELLA PERSONA E FORMALISMO PROCESSUALE – Marcello Adriano MAZZOLA
1. Premessa. - La sentenza dei giudici di legittimità n. 21013 del 13 settembre 2013 è l'occasione sovrana per porre riflessioni sostanziali, solo marginalmente civiprocessualiste, sul rapporto – lo anticipo, malsano – tra formalismo e sostanza nel nostro ordinamento. In particolare sulla posizione dominante del rito processuale nel nostro Paese. Dominante rispetto alla sostanza, all'anima, dei diritti della persona. Ergo, rispetto alla salvaguardia dei diritti stessi.
Chi scrive, e riflette ora, ha avuto il piacere di laurearsi 22 anni fa con il prof. Crisanto Mandrioli, dunque non ha certo in odio il diritto processuale civile. Rimane però da domandarsi cosa sia rimasto della rotta tracciata dal prof. Francesco Calamandrei (insieme al prof. Carnelutti) con il codice di rito del 1942, secondo gli insegnamenti impartiti dal prof. Chiovenda. Anche se di recente qualcuno ne ha messo in discussione il rapporto e secondo altri il codice di rito ha avuto comunque un'impronta autoritaria. La storia civilprocessualistica italiana richiederebbe un esame organico per comprendere quali tormenti ed influenze abbia subito nel tempo. Così da riuscire a focalizzare lo stato dell'arte oggi. Non avendone né il tempo né soprattutto le capacità rimando ad uno scritto molto rappresentativo al riguardo (Michele Taruffo, La giustizia civile, Il Contributo italiano alla storia del Pensiero – Diritto, 2012, in http://www.treccani.it/enciclopedia/la-giustizia-civile_(Il-Contributo-italiano-alla-storia-del-Pensiero:-Diritto)/).
Certo l'inizio del novecento, nelle prime tre decadi, è contrassegnato dai progetti di riforma Chiovenda (1919), Mortara (1923) e poi Carnelutti (1926), spesso in contrasto tra di loro, a conferma di un fermento e di un dibattito complesso. Complessità che in qualche modo non svanisce nel codice di rito del 1942, ancora oggi in parte vigente, come testimoniato di recente: "La proposta di riforma viene dunque rielaborata, e si giunge nel 1939 al 'progetto definitivo Solmi', nel quale è fortemente attenuato il rigore di molte soluzioni che erano presenti nel progetto del 1937. La versione del 1939 costituisce la base per la redazione finale del codice da parte di una commissione nominata dal ministro Dino Grandi, che in realtà lavora per mezzo di un comitato ristretto composto da Calamandrei, Carnelutti e Redenti (e dal magistrato Leopoldo Conforti). Il comitato produce un testo che viene ulteriormente riveduto (essenzialmente da Conforti), e che viene approvato e promulgato il 28 ottobre 1940, per entrare in vigore il 21 aprile 1942 (Taruffo 1980, pp. 253 e segg.). Vale la pena di ricordare queste vicende assai complesse per alludere alle ragioni che portano, nella redazione finale del codice, assai lontano dall'impostazione rigorosa che aveva caratterizzato il progetto del 1937. In realtà il codice è il frutto di un compromesso sistematico tra chi – anche in mancanza di una concezione fascista del processo – mira a un rafforzamento del ruolo del giudice e a una limitazione dell'autonomia delle parti, e chi è sostanzialmente contrario a innovazioni radicali, come la maggior parte della dottrina e della professione forense. Inoltre, il codice ha un carattere marcatamente dottrinale e riflette l'impianto sistematico dei trattati di diritto processuale, oltre che le soluzioni elaborate dalla dottrina a proposito di numerosi istituti del processo. Nel codice non si esprime una teoria omogenea e coerente del processo civile, poiché una teoria siffatta non era stata costruita dalla dottrina. Anche a livello teorico si trovano soluzioni di compromesso: si accolgono alcuni aspetti del pensiero chiovendiano ma senza attuarli in modo effettivo. Non è dunque attendibile la tesi, proposta soprattutto da Calamandrei, secondo la quale il codice sarebbe il frutto della dottrina chiovendiana: esso è certamente il frutto della cultura processualistica dell'epoca, ma Chiovenda fu solo un esponente, influente ma spesso discusso e contestato, di questa cultura (Taruffo 1980, pp. 281 e segg.). Quanto alla questione – sollevata anche di recente da Franco Cipriani – se si tratti di un codice fascista (Cipriani 2002) la risposta non può che essere negativa. Da un lato, le novità che il codice contiene rispetto al codice del 1865 non sono affatto dovute a una concezione fascista della giustizia civile, per la semplice ragione che essa – come si è detto – non esisteva. Esse derivano dal fatto che la dottrina – malgrado numerose incertezze e divergenze – aveva in qualche modo elaborato un modello di processo che si poneva al passo con i tempi, senza rinunciare, pur in presenza di un ruolo relativamente attivo del giudice, ai tradizionali principi attinenti ai diritti e ai poteri delle parti. Dall'altro lato, bisogna distinguere tra il codice e la Relazione che lo accompagna, nella quale non mancano espressioni di omaggio e di esaltazione del regime. Peraltro, l'autore della Relazione è Calamandrei, che certamente fascista non è, ma in realtà queste espressioni furono aggiunte all'ultimo momento dal magistrato Giuseppe Chiarelli, anche in ragione del fatto che la stessa Relazione sarebbe stata sottoscritta dal ministro della Giustizia del governo fascista." (Michele Taruffo, cit.).
Tale ampia discussione attiene ai principi che sorreggono il codice di rito del 1942. Spiega assai meno la ratio di tutte le novelle che si sono succedute da allora sino ad oggi, apparentemente accomunate però da un'unica stella polare: la razionalizzazione del processo civile, la celerità, l'efficienza, da ultimo l'ossessione per la necessità di deflazionare il carico del processo civile, oramai collassato da un numero abnorme di liti pendenti (con numeri cangianti che, a seconda dei convegni e della platea, giungono sino a 5 milioni).
Questa foga (oramai quasi una psicopatologia) nel voler pochi processi, veloci, efficienti è in realtà originata ed alimentata dallo stesso male che però si trascura di combattere: un'architettura processuale complessa, eterogenea, non trasparente, responsabilizzante solo in parte, iper formalistica, punitiva ma in modo schizofrenico, il tutto accompagnato da una disorganica riforma della giustizia civile (con un processo civile telematico balbuziente e assai incompleto, oltre che complesso; con un'assoluta indulgenza verso la carenza di diligenza della magistratura e verso l'inefficienza amministrativa) (si rimanda all'uopo a Mazzola M.A., "Responsabilità processuale", Utet, 2013).
2. La Costituzione ed il processo. - Come ci ricorda la migliore dottrina, tuttavia "La Costituzione del 1948 contiene l'enunciazione delle garanzie fondamentali del processo, dai diritti di azione e di difesa all'indipendenza dei giudici e all'obbligo di motivazione delle sentenze. Tuttavia, i processualisti non sembrano rendersene conto per almeno una ventina d'anni, immersi come sono nelle loro prospettive concettualistiche. Le sole eccezioni sono rappresentate, nel 1954, da Processo e democrazia di Calamandrei (che era stato membro della Costituente) e, tra il 1955 e il 1957, da alcuni scritti giovanili di Mauro Cappelletti (poi ripresi nel 1968), allievo di Calamandrei, che per la prima volta in Italia affronta il tema del controllo di costituzionalità delle leggi." (Michele Taruffo, cit.). Or bene, mi pare che le riflessioni di Taruffo, paradossalmente siano ancora attuali, atteso che le garanzie fondamentali del processo dettate dalla carta costituzionale paiono ancora oggi in larga parte inattuate (si pensi solo all'integrità dell'esercizio del diritto di difesa, al principio del giusto processo, ed anche in relazione al principio di uguaglianza).
Oggi, così come ci spiega Ernesto Lupo, primo Presidente della Suprema Corte di Cassazione, "quasi il 50% delle decisioni dei processi civili in Italia, risolverebbe solo questioni di rito e non di merito" (Ernesto Lupo, Primo rapporto sulla giustizia civile in Italia", in La prev. Forense, 2012, n. 3, 264). E' un dato impressionante ma direi imbarazzante e soprattutto umiliante. Tale da spiegare, con uno sterile numero, già tutto. Senza voler affrettarmi verso la conclusione di una tematica assai ampia, vorrei però evidenziare come questo sia il maggior problema nel nostro ordinamento oggi (ed in realtà da tempo, posto che già nel dopoguerra si denunciava un alto numero di processi pendenti): una Giustizia governata e dominata da discussioni formali (di rito) e non sostanziali (di merito). Una discussione sterile, controproducente, irritante. Dunque palesemente inefficiente.
Personalmente lo denuncio da tempo, ossia da almeno 15 anni, quando mi sono dovuto appassionare anche al perenne (ancora oggi) conflitto di giurisdizione tra giudice Ordinario e giudice Amministrativo. Perché anche tale discussione vi rientra appieno. Il formalismo si alimenta non solo con una florida produzione di norme che cesellano una forma come aspetto prevalente sulla sostanza ma anche con un compendio normativo poco chiaro, poco trasparente, che crea ambiguità, promiscuità. Alimentando con ciò un "barocchismo giuridico" che certamente determina una vivacità di pensiero, una ricchezza intellettuale ed infinite gamme dottrinali e giurisprudenziali. Ma che alla fine demoliscono la certezza del diritto. E con esso, annichiliscono i diritti delle persone. Ponendoli in balia delle onde, del momento, del vento. Diritti che fluttuano a seconda della corrente (di pensiero) e del contesto storico. Una fluttuazione grave e non più tollerabile.
Come definire ed allocare questioni irrisolte (e oramai irrisolvibili se non facendo tabula rasa di norme incerte), quali: la concorrenza ed il conflitto tra giurisdizione Ordinaria e giurisdizione Amministrativa, nonché tra le stesse giurisdizioni di merito a seconda del luogo geografico; l'applicazione del codice di rito al processo amministrativo, a lungo trascinatosi nel tempo; le infinite trappole e i mille rigagnoli procedurali riposti nel processo d'esecuzione che alienano i diritti del creditore; la moltiplicazione dei riti processuali con l'incertezza sul tipo degli atti introduttivi e l'applicabilità di alcune norme rispetto ad altre; la vanificazione delle potenzialità del processo sommario; il pernicioso dualismo tra termini perentori e termini ordinatori; la complessità e la follia che caratterizza la notificazione degli atti processuali; la retroattività delle norme; il principio dei diritti quesiti. Solo per citarne alcuni, tra gli infiniti esempi che si potrebbero stilare.
Allora è forse giunto il momento di chiedersi e domandarsi se vogliamo costruire (e subito) un processo moderno, realmente pratico, connotato da efficienza e tale da salvaguardare i diritti delle persone, restituendo un ruolo ed una dignità alla Giustizia. O se vogliamo continuare a mantenere questo obbrobrioso sistema che svilisce e mortifica la dignità delle persone.
Il quesito non è di poco conto. Il sistema di tutela dei diritti (non patrimoniali e patrimoniali) dipende da tale snodo.
3. La sentenza Cass., sez. VI, 13 settembre 2013, n. 21013. – La sentenza del giudice Supremo interviene in un ambito estremamente delicato per la condizione di una persona (la sua interdizione, dunque l'eviscerazione della sua capacità) e per tale motivo pretende ancor di più senso di responsabilità. La vicenda nella specie è assai semplice. A seguito della pronuncia di interdizione da parte del giudice di primo grado, il difensore dell'interdetto propone appello depositando il ricorso invece che notificandolo nel termine con atto di citazione. La Corte di appello di Venezia ha quindi dichiarato inammissibile l'appello per decorrenza del termine di impugnazione di trenta giorni dalla data di notifica della sentenza di primo grado. Col successivo ricorso in cassazione, il nuovo difensore (dunque non quello incorso nel supposto errore formale, in appello), ha motivato ampiamente e riccamente le ragioni per cui la Corte d'appello avrebbe comunque dovuto tenere salvo il ricorso. Se nonché, il giudice di legittimità ha confermato le ragioni del giudice del gravame: "La giurisprudenza di questa Corte è da tempo orientata nel ritenere che il processo di interdizione o inabilitazione ha per oggetto un accertamento della capacità di agire che incide sullo "status" della persona e si conclude con una pronuncia qualificata espressamente come sentenza, suscettibile di giudicato. Le peculiarità di detto procedimento, determinate dalla coesistenza di diritti soggettivi privati e di profili pubblicistici, dalla natura e non disponibilità degli interessi coinvolti, e specificamente segnate dalla posizione dei soggetti legittimati a presentare il ricorso, i quali esercitano un potere di azione, ma non agiscono a tutela di un proprio diritto soggettivo (art. 417 c.c.), dalla previsione che essi possono impugnare la sentenza, pur se non abbiano partecipato al giudizio (art. 718 c.p.c.), e dagli ampi poteri inquisitori del giudice (art. 419 c.c., e art. 714 c.p.c.), non escludono che esso si configuri, pur con tali importanti deviazioni rispetto al rito ordinario, come un procedimento contenzioso speciale, ritenuto dal legislatore come il più idoneo ad offrire garanzie a tutela dell'interesse dell'interdicendo e dell'inabilitando e ad assicurare una più penetrante ricerca della verità, e che quindi esso resti disciplinato, per quanto non previsto dalle regole speciali, dalle regole del processo contenzioso ordinario, ove non incompatibili (cfr. fra le altre Cass. civ., sezione 1^, n. 17256 del 24 agosto 2005)
14. Il giudizio di appello avverso la sentenza del Tribunale di Vicenza dichiarativa dell'interdizione di Fe.Vi. doveva dunque essere proposto con atto di citazione perchè le regole speciali dettate per il giudizio di primo grado non possono ritenersi automaticamente estensibili anche a quello d'appello, in mancanza di una espressa previsione normativa in tal senso (cfr. Cass. civ., sezione 1^, n. 11305 del 30 dicembre 1994 secondo cui l'impugnazione della sentenza che ha pronunciato l'interdizione o l'inabilitazione, in mancanza di diverse indicazioni legislative, deve essere proposta, non già con ricorso, bensì, secondo il principio generale stabilito dall'art. 342 c.p.c., con citazione da notificare alle persone indicate dall'art. 719 cod. proc. civ. nel termine di trenta giorni dalla notifica della sentenza del tribunale).". (Cass., sez. VI, 13 settembre 2013, n. 21013).
Ora, non è mia intenzione certo ribadire le ragioni tecniche profuse nel ricorso rigettato, né entrare nel merito delle argomentazioni della cassazione. Mi limito però ad osservare come nella fattispecie l'appellante abbia certamente manifestato l'intenzione di impugnare il provvedimento di interdizione nel termine breve prescritto dal codice di rito. Può non essere sufficiente una tale manifestazione di volontà interposta nel termine da parte dell'interdetto? Può prevalere una lettura formale (atto di citazione e non ricorso) sulle preziose ragioni sostanziali riposte nell'appello?
Ecco, questo è l'interrogativo che io pongo a tutti noi.
Occorre notare come il diritto oramai sia divenuto, perlomeno in Italia, la tomba dei diritti, sommersi da una stratificazione normativa abnorme, incomprensibile (spesso originata da legislatori incapaci, mediocri o volutamente in mala fede) ed incerta. Per gli stessi operatori del diritto. Immaginatevi per l'uomo medio.
Una pericolosa involuzione, una deriva inquietante, a mio avviso autoritaria (perché mina la stessa libertà). E che dobbiamo invertire subito.
E' dunque oggi necessario ripartire dalla lettura di Montesquieu [Lo spirito delle leggi (L'esprit des lois)] e riflettere sull'avversione al dispotismo, che può ben realizzarsi anche mediante il potere legislativo. Avallato da una lettura formalistica delle norme.