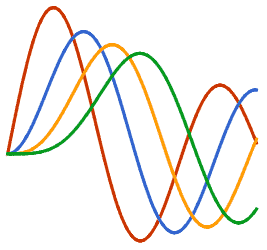- Trisolino Luigi - 23/04/2015
AUTONOMIA TESTAMENTARIA: DISCIPLINA, FENOMENOLOGIA, ERMENEUTICA – Luigi TRISOLINO
-Interpretazione delle clausole testamentarie e questione analogica
-Filosofia della dialettica come strumento utile nell"approccio ermeneutico complesso ed evolutivo
-Esegesi dei passi di Giampiccolo e di Lipari nello studio del pensiero della dottrina sulla diseredazione, sul testamento e sulla autonomia dei privati
La problematica circa l"interpretazione delle clausole testamentarie, affrontata in un"ottica che tiene quanto meno conto della teorica della negozialità dell"atto, ha preso le mosse dal dovuto riferimento all"art. 1324 c.c., sul quale anche abbastanza recentemente la dottrina contemporanea ha riflettuto. A fronte di una scuola tradizionale secondo la quale, per quanto riguarda le lacune palesate dalla disciplina del testamento – o degli atti di diritto di famiglia – che sembrano essere non altrimenti colmabili, "potrebbe pur sempre farsi ricorso, se non alle norme degli artt. 1321 ss., ai principi generali che [da esse] … è possibile estrarre" (CARRESI), una scuola di pensiero che si potrebbe definire intermedia, tra la difesa della roccaforte della contrattualistica, da un lato, e l"apertura dei principi ermeneutici del contratto in generale alla figura del testamento in virtù della comune derivazione dal ceppo negoziale, dall"altro lato, consegna alla storia della dottrina italiana in materia, il parere secondo il quale l"art. 1324, se varrebbe a tracciare un limite alla capacità espansiva delle norme dedicate al contratto, non implica tuttavia l"esclusione della possibilità di applicare le norme stesse al di fuori della sfera degli atti tra vivi a contenuto patrimoniale, bensì implicherebbe soltanto che una tale applicazione "deve essere controllata di volta in volta", e non "aprioristicamente affermata sulla base di una ritenuta unitarietà della categoria negoziale" (G. B. FERRI). Una visione questa che, come è stato abbastanza recentemente rilevato (DELLE MONACHE), sempre nel periodo storico della dottrina precedente alla sent. n. 8352/2012, non è distante dalla concezione di chi sostiene che agli atti non contemplati dall"art. 1324 c.c. la normativa sul contratto possa comunque essere utilizzata attraverso il procedimento analogico, come qualche autore ha voluto chiarire (PIETROBON). In definitiva, si dia l"onore di chiudere questa argomentazione intorno alla funzione e ai limiti dell"art. 1324 c.c., alla dottrina recente a cui poco fa si è fatto riferimento nel coordinare le diverse scuole di pensiero; teorica recente volta a concepire in senso aperto l"articolo "de quo", poiché esso non impedisce assolutamente "che ci si possa avvalere delle "regulae iuris" disciplinanti il contratto allo scopo di completare, allorché se ne manifesti la necessità, il regolamento normativo concernente l"atto testamentario" (DELLE MONACHE).
A ben vedere nell"opera di Lipari, il viavai critico dall"istituto del contratto a quello del testamento non si arresta tanto presto, e l"A. passa a rilevare come non sia nemmeno applicabile al testamento la norma dell"art. 1418 c.c. in tema di nullità, "perché l"indicazione delle cause che producono la nullità certo non può ritenersi operante per il testamento che ha tutta una disciplina autonoma; anzi, il tentativo di uniformarsi alla regola generale configurando ipotesi di nullità del testamento per difetto di causa ovvero per la presenza di una causa erronea, costituiscono niente più che sovrastrutture concettuali, inidonee a spiegare la realtà giuridica anche come semplici strumenti di scuola" (LIPARI). Ugualmente è stato rilevato in riferimento all"art. 1419 c.c. in tema di nullità parziale: "una volta chiarita l"impossibilità di impostare il problema del rapporto tra testamento e singola disposizione testamentaria negli stessi termini in cui si suole porre quello tra negozio nel suo complesso e singola clausola, il riferimento a una nullità parziale, anche a prescindere dalla particolarità della norma di cui al cpv. dell"art. 1419 riferibile esclusivamente al contratto [giacché prevede che la nullità di singole clausole non importa la nullità dell"intero contratto, quando di diritto le clausole nulle sono sostituite da norme imperative; come può ricordarsi, a tutela dei legittimari, in caso di diseredazione di essi non si ha il diretto operare di norme di "ius cogens", dato che è soltanto previsto l"onere in capo ai legittimari stessi di ricorrere alla tutela giudiziale offerta dall"azione di integrazione della legittima], appare impossibile, specie in rapporto al diverso criterio che il legislatore ha utilizzato prevedendo esplicitamente la nullità di singole disposizioni testamentarie" (LIPARI). Più in generale dagli studi e dai rilievi critici e sistematici lipariani, trova conferma l"idea secondo cui il testamento non trova nella propria peculiare disciplina le motivazioni della propria sistemazione dogmatica, e che, a maggior ragione, tale sistemazione non va collegata alla struttura dell"atto nella sua funzione tipica, ma al modo di porsi della sfera effettuale, quindi ai risultati concreti che a quell"atto sono connessi (LIPARI). Leggendo questi ultimi risultati della ricerca lipariana, giunge alla mente una icastica critica in un certo senso di conferma: non si è mica nel platonico mondo iperuranico delle idee, ove i principi e le intrinseche fattezze maiuscole della teoria generale dell"atto e del negozio giuridico, devono scontatamente "sistemare" tutte le frecce nella stessa faretra dogmatico-concettuale.
Le fatiche della maestralmente contorta opera lipariana, presa qui in studio, sembrano riassumersi in una preziosa e saggia indicazione di metodo d"impostazione di quella che chi scrive ha voluto intendere essere la questione della (ri)fondazione della teoria generale del negozio giuridico, ossia della palingenesi, non drastica, della teorica negoziale generale, ove fermo e vivido è "il convincimento che il rapporto tra il dato testuale consegnato nel sistema delle norme e il momento concettuale, attraverso il quale la scienza del diritto, proprio in quanto scienza, non può non passare, è un rapporto dialettico, nel senso che ciascuno dei termini fra i quali intercorre è, in sé nonché nel riflesso con l"altro, mutevole, pur all"interno di un medesimo ordinamento" (LIPARI). Ora, a noi giovani posteri di queste raccomandazioni metodologiche, non tocca fare avanguardistiche fermentazioni epigonali, sterili dogmatismi di un"opera volta a creare più dubbi che dogmatiche e sempre certe verità giuridiche (troppi epigoni conta la storia delle correnti di pensiero nate scevre da ideologismi); a noi giovani posteri spetta anzitutto il compito di approfondire le prospettive, saggiandole e, quindi, testandole nella realtà concreta in continuo mutare. Quindi, dall"invito lipariano, bisognerebbe sviscerare i termini e i concetti, non tanto trarre freddi nozionismi accelerati. In primo luogo balza alla mente rilevare i termini che si potrebbe osare nell"indicare come di dialettica battaglia, ossia la disciplina normativa da un lato e il concetto dall"altro; in secondo luogo, constatare il tipo di "feeling" che li mette in correlazione, ossia la dialettica; e poi, infine, iniziare il giuoco senza fine, ossia seguire il loro stesso rapporto dialettico, che catullianamente ha al contempo punte di odio e di amore. Scrutare quindi nello scibile filosofico che ha parlato di dialettica, per esempio considerare la dialettica hegeliana la quale vede dispiegate una "thesis" dinnanzi ad una "anti-thesis", per poi avere una "s(i)un-thesis" quale riaffermazione della tesi; oppure il più dirompente e meno circolare prospetto dialettico marxiano (sicuramente culturalmente speso nella concezione storica lineare e laicamente edenica del trionfo della lotta delle classi subalterne), ove tesi e antitesi in realtà sembrano lavorare materialisticamente per l"avvento di una sintesi che sia progresso e dia sfogo al divenire civile quale necessità storica, in un"ottica disalienazionistico-liberazionistica. Poco sopra – è bene sottolinearlo – si discorreva di giuoco senza fine, nell"attività dello scrutinio dello svolgimento dialettico, poiché è "regula" della pura logica che in una dialettica complessa, che non voglia restare un mero schemino per discenti appena iniziati alle arti filosofiche, la sintesi diviene a sua volta tesi di una diversa antitesi, in un circolo che sembra vizioso, ma a cui in verità un tale attributo di valore non si addice, giacché ci si assumerebbe sennò d"appiopparlo al fluir della vita stessa. Bene, forti di queste premesse, norma e concetto sono l"una lo spauracchio limitante dell"altra e viceversa, o sono commilitone pronte a ridimensionarsi (o a farsi vicendevolmente ridimensionare) al fine di lavorare fianco a fianco nella costruzione di una certezza del diritto che abbia alla propria base la cultura della sinergica cooperazione degli ingranaggi dell""ars iuris"? Sovviene comunque spontaneo il quesito se sia la norma a trarre vita dal concetto – il quale quindi assumerebbe una iniziale sorta di esistenza pregiuridica, un proprio stato di natura prima del suo debutto solenne nel mondo della forma – ovvero se, al contrario, sia il concetto a scorgere la propria genesi nella norma e a seguito dell"inizio della vigenza della norma. Ma, potrebbe obiettarsi che, qualora questa seconda ipotesi fosse scelta per un istante come quella accoglibile, e che, se superficialmente una siffatta constatazione sia valida perché vera e quindi verificabile nell"esperienza, tuttavia non si riuscirebbe a comprendere, volendo sondare più a fondo, su quali basi pure (scevre) il dato della norma si basi, per poter poi dar vita, e non semplice formulazione positiva, a un concetto: dovrebbe pur sempre esserci un dato valoriale (seppur magari non ancora catalogato come concetto), il quale non è dato concepire quale il frutto di un semplice procedere per libere idee fluenti; si andrebbe a ritroso aizzando una vera e propria caccia al tesoro valoriale, concettualmente formulabile "in potentia" (quindi ricollegabile a un insieme sistemico categorico astratto), giacché anche i concetti vanno affinati e studiati prima e dopo la loro enunciazione; in questa ricerca a ritroso viene in mente il naturale limite umano del non poter procedere compiutamente verso l"infinito col (semplice) raziocinio, e, nel riconoscimento di questa sostanziale finitezza sempre curiosa, il dispiegarsi di millenarie sentenze filosofiche, quale il fermo aristotelico dello pseudo-divino primo motore immobile ("πρῶτον κινοῦν ἀκίνητον"), che chi scrive vuol collegare, laicamente, al concetto kelseniano di "Grundnorm", valida, appunto, in quanto presupposta valida, giacché – a rigor logico – norma non posta. In fin dei conti, ritornando sui binari della conclusione lipariana oggetto della presente attenzione, ad avviso di chi scrive, norma e concetto devono collaborare per una qualitativamente più arguta certezza del diritto e coerenza del sistema giuridico, il quale ultimo, in un"èra in cui il diritto naturale è fuori moda, data l"ancora dolce vita del neopositivismo bobbiano, suole esprimersi nella forma del dato positivo, comunque sempre interpretabile con tutti gli strumenti a disposizione e da tutte le anime giuridiche (la dottrina e la giurisprudenza in prima linea, la legge di interpretazione autentica in seconda nonché straordinaria linea).
Si può ritenere, proprio a risaltare il momento positivo (leggasi normativo), che l"autorevole genio di Lipari lanci un ultimo consiglio che ha tutta l"aria di essere anche un monito, ossia che il problema del rapporto tra autonomia privata e testamento non può risolversi "in un rigido contrappunto di categorie concettuali, dato che così si finirebbe per perdere di vista la funzione pratica e diagnostica della categoria" (LIPARI). Bisogna, infatti, che gli scienziati del diritto ammettano che il concetto, la categoria, il piano mentale legislativo attingibile dalla "ratio" delle norme debbano farsi serve creative – in senso analitico – della "praxis"; tuttavia sovente accade che, nel regime filosofico della torre eburnea, hegelianamente i servi diventano padroni e i padroni servi, il che, se dall"approfondimento di una parte della sinistra hegeliana nella realtà ottocentesca ciò possa ricondursi a piacevoli evoluzioni, nel mondo dei fragili equilibri tra dogma e concretezza non può che condurre al fastidio di vedere l"effettività materiale incastrata fra le trame delle platoniche favelle delle scuole.
L"apparente antitesi tra autoregolamento e fattispecie positiva, nella drammaticità di questo momento di contrapposizione insinuante quasi una sorta di dubbio amletico, impone una lucida considerazione dell"analisi, svolta dalla risalente dottrina, in tema di teoria generale dell"atto giuridico e di ultima volontà in particolar modo, anche ai fini che nel presente lavoro più interessano.
In un"etica negoziale che ripari i propri occhi focalizzandoli totalmente sulla funzione "mortis causa" o meno di un atto giuridicamente rilevante, teorica che finisce spesso per ergere aprioristicamente cieche barriere tra contratto e testamento, spicca quella dirompente lezione (dedita a far della logica concettuale la propria stella polare) in cui viene rilevato con tono dotto come "La verità è invece che, quando sul piano concettuale deve ammettersi […] che nella nozione di atto mortis causa possa rientrare anche il contratto (e la circostanza che il nostro ordinamento ciò escluda, per il divieto dei patti successori, non giustifica ovviamente una restrizione della categoria, e del concetto, dell"atto mortis causa), non si riesce più ad intendere […] la stessa utilità sistematica di una distinta classificazione delle due categorie"; "fra un contratto mortis causa e un contratto non mortis causa, quando se ne eccettui il divario funzionale, non pare possano sussistere tali differenze di carattere da giustificare la costruzione di due categorie dogmatiche contrapposte" (GIAMPICCOLO). In quest"ottica volta (non tanto ad una più radicale plotiniana "reductio ad unum", quanto ad una pura, ordinata, razionale) "recondutio ad unum" dei concetti di testamento e di contratto, che come meteore errabonde infestavano l"universo della categoria negoziale con la presunzione narcisisticamente autocelebrante di essere troppo diversi tra loro, appare opportuno rinsaldare brevemente il chiarimento circa la struttura e la funzione del concetto in generale, per esser forti di un sostrato culturale che permetta di affrontare meglio lo studio critico del pensiero di Giampiccolo. Per far ciò, quale pensatore potrebbe eleggersi a guida illuminata se non Kant, il quale scriveva che "La categoria non ha altro uso alla conoscenza delle cose che di esser applicata agli oggetti dell"esperienza. Pensare un oggetto e conoscere un oggetto non è dunque la stessa cosa. La conoscenza comprende due punti: in primo luogo, un concetto per cui in generale un oggetto è pensato (la categoria), e, in secondo luogo, l"intuizione, onde esso è dato" (KANT); nella visione kantiana, quindi, viene preso in esame il processo formativo dei concetti attraverso le categorie e il loro rapporto con un materiale sensibile preordinato secondo intuizioni pure (lo spazio e il tempo concepiti quali forme pre-sussistenti del nostro "cognoscere"); nel suo impianto speculare il filosofo, in virtù della propria convinzione per cui l"unificazione del molteplice non è fatta dalla sensibilità ma da un"attività sintetica che ha sede nell"intelletto, attribuisce ai concetti il carattere di funzioni che riordinano e unificano più rappresentazioni.
In virtù della disamina teorico-concettuale, pura, dell"atto giuridico, Giampiccolo conclude per l"ingiustificabilità in linea astratta del contrapposto sistematico atti "inter vivos" – atti "mortis causa", giacché "La verità è che una piena contrapposizione, e feconda dal punto di vista sistematico, è possibile soltanto fra atti inter vivos e negozi di ultima volontà, e cioè fra questa particolare species dell"atto mortis causa [il testamento] e tutti i rimanenti negozi, siano o non – a loro volta – mortis causa" (GIAMPICCOLO). Convenendo favorevolmente su questo fine rilievo logico, per restare fedeli ai paletti trattativi che ci si è precedentemente posti con l"obiettivo di non precipitare nel bozzettistico abisso dell"ipòstasi, si passi a considerare i risvolti pratici dell"appena vista contrapposizione (atti "inter vivos" – negozi di ultima volontà): per l"Autore solo riferendosi a siffatto "più limitato aspetto", "ha ragione d"essere, e trova anche conferma nelle norme di diritto positivo, una sensibile differenza di categoria con riferimento ai vari problemi della capacità, della volontà, dell"interpretazione, etc." (GIAMPICCOLO); non uscendo del tutto fuori, così, da quel groviglio spinato di quesiti sorti intorno alla elasticità normativa dell"art. 1324 in tema di interpretazione testamentaria.
Per quanto concerne la negozialità del testamento, nel 1954, anno in cui l"opera del Giampiccolo è editorialmente apparsa, lo stesso A. fugava ogni dubbio, costruendo sulla convinzione per cui "l"atto di ultima volontà non può essere se non un negozio giuridico" il dato alquanto suggestivo pur nella sua minuzia, che rileva come sia anche chiaro che "quel contrapposto sistematico (atti inter vivos – atti di ultima volontà) possa valutare soltanto il campo del negozio e non anche quello dei meri atti giuridici" (GIAMPICCOLO).
Tra i negozi "mortis causa", togliendo i patti successori (vietati dal nostro ordinamento ai sensi dell"art. 458 c.c.), la "donatio mortis causa" (in diritto romano, ogni negozio giuridico, traslativo del "dominium" su una "res" dal donante al donatario, in cui risultassero fuse la "causa donationis" e la "causa mortis", ossia l"intento di arricchire immediatamente il donatario in vista di un pericolo imminente di morte, e quindi della premorienza del donante al donatario; Giampiccolo stesso, pur elencandola, non la ritiene un atto "mortis causa" in senso tecnico, e già sotto la vigenza del codice del 1865 si riteneva nulla in virtù del carattere essenziale della irrevocabilità della donazione), togliendo l"aumento dotale o sopradote (appartenente al più ampio "genus" della controdote, la sopradote era il lucro dotale convenuto nell"allora contratto matrimoniale a favore della moglie, per cui questa, in caso di scioglimento del matrimonio per premorienza del marito, aveva diritto a una quota dei beni di lui commisurata all"ammontare della dote; il lucro dotale era stato abolito al tempo in cui l"A. scriveva l"opera qui presa in considerazione, ma l"istituto della dote sarà definitivamente abolito solo con la riforma del 1975), togliendo il mandato ("inter vivos") "post mortem exequendum" (contratto di mandato la cui peculiarità consiste nel prevedere un incarico che il mandatario deve compiere successivamente alla morte del mandante; non deve trattarsi però di attribuzione di beni "mortis causa" neppure in via indiretta; in verità, Giampiccolo distingue tra mandato "inter vivos post mortem exequendum" e mandato per atto di ultima volontà, sostenendo che solo quest"ultimo sia una disposizione di ultima volontà, costituendo il primo un contratto che si perfeziona durante la vita del soggetto, dispiegando sin da allora efficacia; rileva anche, però, che lo stesso mandato "inter vivos" abbia una sostanziale finalità "mortis causa"), togliendo anche il patto di fiducia testamentaria (ove il fiduciario risulta investito, nel peso della propria coscienza, dalla obbligazione meramente naturale di dar seguito alle prescrizioni, spesso segrete, del fiduciante ormai defunto, col fine di ritrasferire l"attribuzione patrimoniale ad un terzo), "non sembra che altri negozi a causa di morte possano risultare ammessi oggi dal nostro ordinamento che non siano anche atti di ultima volontà", con la conseguenza che "unica specie di negozio mortis causa ammessa nel diritto vigente è il negozio mortis causa unilaterale, propriamente detto di ultima volontà" (GIAMPICCOLO).
Sempre nell"opera di affratellamento dei concetti sotto il comune tetto della categoria negoziale, e sotto la rinnovata luce che la sfumatura della negazione della contrapposizione atti "inter vivos" – atti "mortis causa" ha proiettato sullo scenario della formalizzazione dei comportamenti umani (giuridicamente rilevanti e caratterizzati da una peculiare spinta autonomistica in capo ai privati), si veda l"ennesima convinzione dell"A., questa volta sull"elemento che da sempre pare esorcizzare – nel senso figurato del termine – il dato della negozialità che investe il testamento, o più in generale l"atto di ultima volontà: la morte. La convinzione dell"A. a cui si faceva riferimento è quella concretatasi nella seguente massima dottrinaria lucifera (non diabolica bensì, etimologicamente, portatrice di luce) nelle "tardoesoteriche" nebbie brune del sistema negoziale: "la morte è un fatto naturale [e fin qui, "nulla quaestio"] estrinseco alla fattispecie formativa del negozio e legato a questa soltanto sotto il profilo funzionale" (GIAMPICCOLO).
Altro aspetto critico e innovatore, questa volta specificamente connesso al negozio testamentario, è nel pensiero dell"A., il problema della natura della revoca del testamento, e della revocazione della revoca stessa; mentre la revoca del testamento, qualunque sia la forma con la quale viene posta in essere, non è un atto "mortis causa" (è un semplice atto che ha lo scopo di eliminare un atto "mortis causa" di ultima volontà), la revoca della revoca, costituendo una volontà negativa che si sovrappone ad un"altra volontà di segno negativo, implica necessariamente un risultato finale di segno positivo (potrebbe dirsi, come nella grammatica latina, in cui due negazioni affermano), un risultato di ristabilimento della volontà negoziale "mortis causa" del testamento, quindi dal punto di vista funzionale un testamento "per relationem", ossia un atto "mortis causa". Se ad un tale chiaro ordine di idee è pervenuta la fatica dottrinaria del Giampiccolo, non tanto chiaro è il parere di quell"altra parte della dottrina, la quale da un lato qualifica nella revoca della revoca un caso di valido testamento "per relationem", dall"altro sembra confutare siffatto concetto quando sostiene che il testamento rivive così come era prima della revoca, con la sua data di allora, a cui si deve far riferimento nel risolvere le questioni connesse (MESSINEO). Lo stesso Giampiccolo, dinanzi a questo orientamento in materia, appare adocchiare un atteggiamento contraddittorio, giacché da un lato si è ammessa l"esistenza di un (secondo) testamento "per relationem" nella revoca della revoca del (primo, originario) testamento, e dall"altro lato si è smentita l"esistenza stessa di un secondo testamento nel riconoscimento di una reviviscenza, con la data medesima del primo testamento ai fini della risoluzione delle questioni che all"atto di ultima volontà sogliano connettersi; ciò è ampiamente comprensibile nella semplice domanda retorica che Giampiccolo pone e, prima ancora di porla, si pone, ossia (GIAMPICCOLO).
Parlando quindi più da vicino del testamento, l"A. si presta a chiarificazioni generalmente assunte tra gli studiosi della materia, affermando che la unilateralità della manifestazione risulta essere requisito indispensabile della sua validità, sottolineando come la forma unilaterale non sia soltanto condizione sufficiente ma altresì necessaria, affinché l"atto dispieghi i suoi effetti. Tale ultimo carattere è da ricollegarsi al principio della c.d. spontaneità dell"atto, principio peculiare del negozio "mortis causa" nel nostro ordinamento e che spiega perché il nostro diritto positivo ammette solo il negozio di ultima volontà quale atto "mortis causa" (GIAMPICCOLO). Stante nel nostro codice, all"art. 589, il dato normativo che vieta il testamento collettivo (congiuntivo e reciproco), si riconosce esplicitamente il carattere della unipersonalità, requisito particolare del testamento, e non in generale del negozio di ultima volontà (GIAMPICCOLO), di cui l"atto testamentario è "species" nella teorica concettuale pura dell"atto giuridico.
Un altro versante, all"interno del campo negoziale puro, dove l"opera del Giampiccolo tende ad innovare, è quello attinente all"errore ostativo, ossia al "lapsus" nel quale non c"è stato un errore di rappresentazione della realtà, al contrario dell"errore vizio ove questa falsa rappresentazione della realtà sussiste; l"errore ostativo si ha, ad esempio, quando si voleva dire dieci ma si dice cento, e tuttavia dal complesso dell"atto o da altre circostanze, a seconda dei frangenti in cui il "lapsus" si manifesta, si comprende trattarsi di dieci e non di cento. L"A. ora oggetto del presente studio critico, convenendo con il pensiero tradizionale, secondo cui l"accertamento dell"errore ostativo costituisce un corollario della interpretazione del negozio, aggiunge che in particolar modo l"errore "de quo" sia un "posterius" rispetto all"interpretazione stessa, poiché "l"errore incomincia ad operare dove il compito dell"interprete si arresta" (GIAMPICCOLO). Espressione questa, in realtà, da intendere con semplicità, per quella che è e per come si manifesta, senza azzardare voli pindarici pronti a farla approdare nel delicato ed intimo piano introspettivo del foro interiore del disponente caduto meramente, umanamente, in un "lapsus". Quindi, "l"errore ostativo verte sulla dichiarazione e non sulla volontà" (GIAMPICCOLO).
La migliore dottrina (il riferimento va subito principalmente al Giampiccolo) ha dimostrato ormai ampiamente e in modo convincente, che il testamento non serve solo a regolare interessi meramente patrimoniali, bensì per dare assetto agli interessi complessivi "post mortem" del soggetto (si veda BARBA). L"A., individua alcune disposizioni (non previste ma non per questo non ammesse o non ammissibili) non attinenti alla sfera della patrimonialità, quali la disposizione con cui il genitore esclude qualcuno dall"ufficio di tutore o protutore del figlio, disposizioni sulle opere dell"ingegno, disposizioni sui ricordi – per esempio fotografici – di famiglia, o sulla propria corrispondenza epistolare (ai tempi in cui Giampiccolo, morto comunque nel 2002, scriveva l"opera qui presa in esame in alcuni suoi passi, ancora non poteva esistere il costume del carteggio cibernetico tra i consociati, ma oggi si aprirebbero anche frontiere di approfondimento sullo "username" e sulla "password" indispensabili ai superstiti del "de cujus" per accedere ai dati a cui un"eventuale disposizione testamentaria possa riferirsi).
Le disposizioni atipiche di natura negoziale che l"A. esamina, come la disposizione di designazione del tutore, o di istruzioni alla madre superstite per l"educazione dei figli (art. 338 c.c., che è stato poi abrogato con L. 151/1975), o una disposizione sui funerali, sul cadavere o su un"opera dell"ingegno, la riabilitazione dell"indegno, la designazione di un beneficiario del contratto di assicurazione vita, o la sua revoca, almeno finché restano non collegate da un nesso di interdipendenza dalle disposizioni attributive di beni, restano indifferenti alla sorte di queste. "La essenziale autonomia che caratterizza le disposizioni atipiche fra loro e rispetto alle disposizioni tipicamente testamentarie, esclude che l"inefficacia dell"una possa estendersi alle altre", e inoltre "La stessa revoca espressa del testamento precedente è una manifestazione di volontà indipendente dalla sorte delle nuove disposizioni"; quindi, ciò ha in conclusione una implicazione causale, ossia il fatto che "le disposizioni atipiche di natura negoziale conservano ciascuna la propria causa originaria, che vale ancora a distinguerle dal negozio del quale vengono a rivestire la forma tipica" (GIAMPICCOLO).
La dottrina, con la vigenza del codice del 1942, ha proposto già da subito, sul testamento, tre visioni differenti facenti capo a differenti scuole di pensiero: il testamento come il negozio "mortis causa" tipico con cui si dispone del patrimonio per il tempo successivo alla morte del testatore (BARASSI AZZARITI MARTINEZ ALLARA MESSINEO); il testamento quale uno dei tipi negoziali "mortis causa" di carattere più generale e a contenuto vario, patrimoniale e non patrimoniale (BARBERO SANTORO-PASSARELLI); il testamento non come un negozio ma come una semplice forma documentale volta ad accogliere una pluralità di negozi "mortis causa" (BETTI). Giampiccolo, anche in virtù del combinato disposto degli artt. 587-588 c.c., secondo cui il testamento è l"atto "di attribuzione" [dice lo stesso A.] operante "mediante l"istituzione di erede e di legatario", ritiene esatta la prima definizione; "Le dichiarazioni di diverso contenuto che in forma testamentaria possano compiersi, ne sussista o non l"unità formale con eventuali disposizioni di beni, non costituiscono testamento" (GIAMPICCOLO). Merita particolare attenzione quest"ultima citazione, poiché sembra a una prima lettura, contrastare con quanto il Barba ha ritenuto fosse stato detto dal Giampiccolo: ad una più approfondita lettura di entrambi questi studiosi, invece, non si riscontrano vere dissonanze, in quanto il Barba ha semplicemente attribuito alla "migliore dottrina" (con riferimento al Giampiccolo) l"apertura di "nuovi importanti itinerari di studio" presso i quali "il testamento non serve a regolare interessi meramente patrimoniali, bensì per dare assetto agli interessi complessivi post mortem del soggetto"; Barba sfoggia il verbo "servire" preceduto dalla particella negativa, raccontando la verità del pensiero del Giampiccolo. Lipari, autore de" "Il contenuto atipico del testamento", sembra comunque vocàto alla considerazione anche della documentalità dell"atto testamento, atto che, però, al contrario della teorica della terza ipotesi sopra citata, ha natura negoziale; non sembra invece altrettanto vocàto (anzi proprio non lo è) alla giusta negazione di sinonimia tra il verbo "attribuire" e il verbo "disporre" dell"art. 587 (giusta in virtù dello spirito del nostro tempo, formalizzatosi nella pronuncia di legittimità del maggio 2012, ma anche di tante altre pronunce giurisprudenziali di merito). Proseguendo la lettura dello scritto del "54, ci si imbatte infatti, in una ingenua interscambiabilità (anche a livello concettuale, ove il Giampiccolo è però forte nella delineazione di una teoria generale dell"atto di ultima volontà) tra i concetti attributivo da un lato, e dispositivo dall"altro. Ove l"A. sembra riscrivere, col fine di adeguare a un"esatta interpretazione logica, il cpv. dell"art. 587 c.c., scrive che "le disposizioni non attributive di beni, che la legge consente siano contenute in un testamento, hanno efficacia se contenute in un atto che ha la forma del testamento, anche se manchino disposizioni di beni"; si può rilevare così una riflessione non accurata, in virtù dei tempi magari ancora non del tutto maturi, circa il peculiare "feeling" di "genus" a "species" intercorrente tra i due termini, baluardi di concetti ben precisi; anche se l"autorevole Giampiccolo si fosse avvalso di questi due termini per non cadere in ripetizioni magari cacofoniche per il lettore, ciò non giustificherebbe la scelta, perché nel diritto, si sa, certe parole sono soppesate sulla libra della logica, soprattutto se vogliono sostituirsi a una norma codicistica (generale e astratta) per meglio coordinarla sistematicamente (tuttavia quello riportato sopra, non è l"unico passo dell"opera in cui traspare la patente d"interscambiabilità terminologica che l"A. si concede, per via del periodo storico privo di quelle ulteriori, successive e chiarificatrici riflessioni giuridico-concettuali di natura tecnica, anche a fronte delle concezioni dominanti, in realtà). Se poi si confronta realmente la spontanea proposta giampiccoliana con il testo reale del cpv. dell"art. 587, il quale recita che "Le disposizioni di carattere non patrimoniale, che la legge consente siano contenute in un testamento, hanno efficacia, se contenute in un atto che ha la forma del testamento, anche se manchino disposizioni di carattere patrimoniale", il duello "face to face" delle due disposizioni, l"una un versante critico propositivo di una specifica lezione dottrinaria, l"altra uno scoglio del diritto positivo codicistico, si può notare come nell"ottica dell"A. venga confuso il carattere della non-patrimonialità con il carattere della non-attribuzione (sicuramente per via di una fretta espositiva incurante del discernimento logico-semantico dei due concetti, discernimento compiuto e solennizzato poi anni e anni dopo anche dalla Corte di Cassazione, nella sent. n. 8352/2012).
L"A. sottolinea poi che il cpv. dell"art. 587 c.c. non attiene solo alle disposizioni atipiche non patrimoniali, ma a tutte le dichiarazioni espresse in testamento non attributive di beni a causa di morte, e quindi a tutte le dichiarazioni atipiche, sia patrimoniali che non patrimoniali, "per le quali una norma specifica richieda, in modo esclusivo o alternativamente ad altra forma, il requisito della forma testamentaria". Quindi, come lo stesso Giampiccolo si premura di sottolineare, il requisito della forma testamentaria può essere integrato da un atto che del testamento abbia la forma ma che al proprio interno, oltre alla dichiarazione atipica, non abbia disposizioni propriamente testamentarie. Volendo, ora, considerare quanto appena sottolineato del pensiero del Giampiccolo sotto il regime logico di una ricostruzione sistematica volta a prelevare, tra le righe delle teoriche negozialtestamentarie, i rilievi utili alla cucitura (termine che non deve suonare come sinonimo di rattoppatura forzata) della figura della diseredazione all"interno del sistema, non sfugga il fatto che l"A. richieda per le "dichiarazioni atipiche", ai fini del loro ingresso nella rosa delle disposizioni testamentarie sotto il regime di forma documentale, appunto, del testamento, il requisito di essere contemplate da una "norma specifica" di aggancio, in modo esclusivo o alternativo, al peculiare entroterra negoziale e alla forma testamentari. Una simile impostazione ricostruttiva della patente d"accesso delle volizioni presso la corte della solennità testamentaria "mortis causa" di ultima volontà, escluderebbe l"ammissibilità della clausola testamentaria diseredativa (la quale a prescindere, per la Cassazione dei nostri giorni non costituisce disposizione atipica ma soltanto innominata), poiché di una norma che legittimi espressamente la facoltà ablativo-destitutiva del testatore nel nostro codice e nelle nostre norme della legislazione speciale non vi è traccia.
A fronte della seguita metodologia contemperante sia il versante del massimario forense-giudiziario di legittimità, sia l"elaborazione scientifica delle scuole dottrinarie, si pone alla mente il dato giurisprudenziale riferibile, nel particolare spaccato della sua odissea, agli anni 1954-1955, in cui appariva l"opera giampiccoliana di (ri)edificazione della teoria pura dell"atto di ultima volontà. La sentenza della Corte di Cassazione del 20 maggio 1954, n. 1608 non è tra le sentenze che aprono le speranze alla serena fruibilità della facoltà propria dell"istituto diseredativo: tale pronuncia di legittimità, infatti, rigetta la teorica della istituzione implicita (a cui sarà spianata la via solo nel "67) postulante una "sostanziale" corrispondenza effettuale e valoriale tra la diseredazione e l"istituzione indiretta di eredi. Uno spirito totalmente differente, orientato verso il riconoscimento di rinnovati orizzonti dell"autonomia dei privati consociati, si ha il 9 settembre 1954 con la sentenza (questa volta, però, di merito) della Corte d"Appello di Firenze; la sentenza autunnale del "54 iniziava a minare alle fondamenta anzitutto il metodo meno chiarificante in tema di diseredazione con cui il Supremo Collegio aveva affrontato, nella da poco trascorsa primavera, la delicata questione dell"ammissibilità e delle implicazioni dell"istituto "de quo". La Corte d"Appello fiorentina, infatti, in quest"occasione ha rilevato come la diseredazione costituisca un atto dispositivo, negativo, del patrimonio, giacché esclude dalla successione i soggetti che altrimenti vi sarebbero chiamati, e declamava la sua piena ammissibilità nel nostro ordinamento. Questa Corte di merito, a dire il vero, non si fece mancare proprio niente, poiché specificava che la frase utilizzata dal testatore "non lascio nulla a mia nipote Giovanna" valeva anche come esclusione dalla successione legittima; questa sentenza, che, dato il percorso seguito di recente dalla Cassazione dovrebbe essere salutata dalla storia della facoltà diseredativa, e più in generale dalla storia dell"autonomia negoziale, quale passo evolutivo di coscienza forense e sensibilità giuridica, ha affrontato lucidamente anche uno dei principali risvolti pratici della diseredazione, ossia la problematica dell"ammissibilità della successione per rappresentazione dei discendenti del diseredato; a dir dei giudici d"appello fiorentini del "54, la volizione insita nella disposizione testamentaria di diseredazione concerne unicamente la persona esclusa e non impedisce, quindi, ai discendenti di quest"ultima di succedere per rappresentazione. Come molto spesso accade nel "cursus" storico di molte battaglie autodeterministiche (si rimembri, per esempio, che l"istituto giuridico del divorzio era presente nel diritto romano, mentre nell"Italia della giovinezza dei nostri nonni non era possibile divorziarsi, e che la "Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio" è approdata nel sistema positivo italiano solo con la Legge 1° dicembre 1970, n. 898, certamente in un contesto socioculturale e giuridico fortemente lontano dall"epoca del diritto romano), a un momento di "rivoluzione" (piccola o grande che sia) segue un momento di "reazione" conservatrice (al di là se più, o meno, cosciente di esser tale in quel dato momento), anche alla sentenza della Corte d"Appello fiorentina succede un periodo giurisprudenziale più timido, che non apporta chiarificazioni della materia (passo che sicuramente sarebbe stato auspicabile attendersi dal Collegio di legittimità). Sintomo di questa "timidezza" espositiva della giurisprudenza successiva, si riscontra nella sentenza n. 3158 della Cassazione del 14 ottobre 1955, ove, se si ribadisce in maniera pure potenziata la questione della successione per rappresentazione ("Salva una diversa volontà del de cujus [tale proposizione di salvezza costituisce appunto la potenziata qualità specificatoria di questa pronuncia rispetto a quella di merito del "54], il discendente legittimo di chi sia stato diseredato dal testatore può succedere a quest"ultimo per rappresentazione" affermava la Corte), non si fa sfoggio della chiarificatrice cattedralità giurisprudenziale di legittimità per sistemare la "quaestio" della diseredazione. Incontestabile alla logica è sicuramente il dato della propedeuticità dell"ammissione dell"istituto diseredativo al riconoscimento della generale successibilità per rappresentazione dei discendenti del soggetto diseredato; ma un siffatto dato, seppur figlio della logica, non è stato adottato dalla esplicita e chiara dicitura della pronuncia "de qua", costituendo, così, un infelice regredire metodologico ed esplicativo sussumibile dalla vaghezza e dalla relativa pochezza dei "verba" del Supremo Collegio nei temi della ammissibilità della diseredazione e, conseguentemente, della sistemazione nomofilattica del senso del concetto dispositivo presente nell"art. 587 c.c. Se poi si considera che l"implicito giudizio di validità della esclusione non risulta attribuibile alla stessa Cassazione, nella vicenda della pronuncia dell"ottobre 1955, dato che sul punto si era formato il giudicato interno per via della mancata specifica impugnazione di esso, si comprende come le critiche che or ora ci si è permessi di avanzare al far della Corte, trovano riscontro negli atti giudiziari della vicenda processuale che fu.
Il testamento come atto negoziale tendenzialmente (auto)determinazionistico è un concetto che, a seconda delle sensibilità civiche e giuridiche, si combina, sposandolo, con la concezione che ravvisa, o pretende di ravvisare, nello stesso testamento un atto a risonanza sociale. A dir di autorevole dottrina, quindi, il testamento si profila quale istituto socialmente rilevante (CRISCUOLI), che consente la esclusiva attuazione e valorizzazione di una molteplicità di interessi a rilevanza effettuale "post mortem" (BONILINI).
Se si prescinde dalle critiche interpretative e dagli orientamenti di pensiero sorti intorno alla definizione codicistica, si può affermare che il testamento è un negozio giuridico tipico, la cui causa è la regolamentazione di interessi "post mortem". Vi è poi chi, più specificamente, individua la funzionalità astratta del negozio testamentario nella regolamentazione programmatica "post mortem" della sorte dei rapporti patrimoniali del "de cujus" (CRISCUOLI). Autorevole è comunque la voce che considera il testamento, tra i negozi giuridici, come il negozio possibilitato a presentare "la più vivace ricchezza di contenuto" (BONILINI), e ricerca la prova del nove di un siffatto dato nello sventagliarsi del c.d. profilo atipico del testamento stesso.