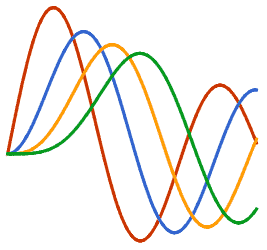Letteratura - Redazione P&D - 12/06/2022
Conti, conteggi e conticini - Massimo Paradiso
Il quarto giorno d’udienze il pubblico sembrava elettrizzato: erano accorsi da tutto il contado per vedere quella gran novità: un Governatore che pareva uno zotico senza istruzione, o almeno un sempliciotto senza arte né parte, e che stava invece dimostrando di essere più saggio di tanti offiziali e notabili del regno. Del resto si vociferava che lui stesso, un po’ sul serio e un po’ per celia, avesse dichiarato che, quanto a ignoranza, quella della sua famiglia e quella di tutti i suoi avi era una ignoranza completa, anzi perfetta perché era una ignoranza senza lacune: ignoravano tutto, senza distinzioni e senza parzialità di alcun genere. Ma Dio, che è Padre di tutti, li aveva compensati con un supplemento di sale in zucca. Così a quanto si sussurrava s’era espresso, non senza una punta di vanità.
Dichiarata aperta l’udienza di giustizia, i primi a presentarsi furono due uomini di mezz’età. Il primo era palesemente un contadino: largo di spalle, magro, scurissimo di pelle per l’intensa abbronzatura, salvo una curiosa “chierica” disegnata sul capo non tanto da una tonsura quanto dalla linea di demarcazione tra il cranio ordinariamente coperto dal berretto e la fronte esposta al sole: cosa che risaltava perché il contadino, com’era ovvio in quella sede, teneva in mano tormentandolo il corresponsabile (in combutta col sole) della chierica di cui sopra. A questa teneva compagnia un’altra chierica, quella di un frate che lo tallonava da presso, ma che si poteva soltanto “indovinare”, atteso che il monaco teneva il capo coperto dal cappuccio, com’era consentito ai chierici di fronte al potere civile. L’abito lo qualificava come francescano e appariva piuttosto trasandato, se non addirittura male in arnese, sia per le condizioni del saio sia per l’aspetto e la postura.
Il secondo a farsi avanti era invece un uomo di mezz’età, che oggi qualificheremmo come possidente, il cui atteggiamento spavaldo, se non arrogante, contrastava non poco con la modestia dell’abito, liso in più punti. S’indovinava comunque, sotto quei panni modesti, l’uomo sicuro dei propri mezzi e abituato a comandare, se non a dominare gli altri. Insomma, un hidalgo della peggiore specie e, precisamente, un conte. Lo tallonava un curioso personaggio: segaligno e allampanato, indossava un lucco nero, che lo qualificava come avvocato, e recava con sé, reggendola sulle due mani, una cartella di cuoio che aveva visto tempi migliori.
«Chiedo giustizia all’Eccellenza vostra – esordì il primo –. Il qui presente don Venancio rivuole indietro il terreno che vent’anni addietro mi ha conceduto e non vuole neppure pagarmi le migliorie che ho fatto in tutti questi anni come mi spetta invece per il contratto che abbiamo firmato anzi io non l’ho firmato perché non so scrivere e l’ho segnato con una croce ma c’ho due testimoni che possono testimoniare che io ho dritto a trent’anni di godimento della terra e poi al pagamento delle migliorie...».
Il contadino riprese fiato e il Governatore ne approfittò per interloquire: «Può bastare, buon uomo. Ho capito. Sentiamo il qui presente don Venancio, come dite voi». Sperava così, il buon Sancho, di risparmiarsi il profluvio di parole e di lamentele che già si preannunciava e sotto il quale era comunque difficile rinvenire la trama dei fatti. Ma mal glie ne incolse, come si suol dire. Il sollecitato don Venancio fece un passo avanti, facendo attenzione a non sfiorare il contadino, e: «Eccellenza Illustrissima, permettetemi anzitutto di presentarmi. Il nobiluomo che ha l’onore di starvi davanti, come a me oggi lietamente occorre, risponde al nome di don Venancio Feliciano Aloa y Gutierrez y Mendoza de la Veda: un nome tra i più rispettati di tutta la Spagna e che certo avrà udito pronunciare molte volte...». Fece una pausa il nostro, come a sollecitare e comunque aspettandosi almeno un cenno di assenso all’asserita notorietà, ma la faccia dell’«Eccellenza Illustrissima» rimase inespressiva, perché si era perduta nel cercare di districarsi tra tanti cognomi.
«Ho avuto sentore – così riprese il nobiluomo – dell’opere di giustizia che, or è ieri, si sono praticate in questo augusto consesso, e perciò mi son detto: “Caro don Venancio, è giunto finalmente chi può dar udienza alle tue sacrosante ragioni”. Ed è ben per questo che mi sono astenuto dal far somministrare all’arrogante bifolco qui presente la lezione che si meritava. Mi appello dunque a quanto l’Eccellenza Vostra Illustrissima appena ieri ha ripetutamente proclamato e declamato come criterio irrevocabile di giudizio, e cioè, cito testualmente, “Caschi il mondo, bisogna stare ai patti. Se no, il mondo finirebbe a rotoli. Bisogna stare ai patti!”. Non è forse questo che l’Eccellenza vostra or è ieri ha solennemente ripetuto a conforto delle umane aspettative di giustizia dei galantuomini, rispettosi della parola data come di parola al pari delle Sacre Scritture sacrosanta?».
«In effetti è così» rispose, ma malvolentieri, l’invocata Eccellenza, che già presagiva come quelle incaute parole, buttate lì per guadagnare tempo e trarsi temporaneamente d’impaccio, gli si sarebbero rivoltate contro. Sembrava evidente, infatti, che l’hidalgo si apprestava a mettere nel sacco l’incauto bifolco con l’ausilio delle “linee programmatiche”, come diremmo oggi, enunciate dal giudice. «Ebbene – concluse l’hidalgo – quest’uomo rifiuta di rispettare i patti a suo tempo sottoscritti, come meglio esporrà l’avvocato Vicente Albacete Inarruri, del foro di Barbastro».
Il procuratore non si fece pregare e, chiesto e ottenuto il permesso di parlare, squadernò con fare solenne la cartella di cuoio e ne mostrò il contenuto: quasi si trattasse di un testo sacro, non osò toccare il documento che vi si trovava ma lo pose sotto gli occhi del giudice, invitandolo a leggerlo. Breve fu però l’imbarazzo del buon Sancho: rammentandosi di come già in precedenza si fosse fatto vanto della sua ignoranza quasi fosse un blasone di famiglia cui non intendeva rinunciare, dichiarò apertamente di non saper leggere. La franchezza priva di inibizioni in tal modo mostrata stroncò sul nascere i sorrisetti di chi già si prefigurava il suo imbarazzo e i contorcimenti per celare quella carenza. L’avvocato, invece, si allarmò non poco – presagendo che il suo compito sarebbe stato più duro di quanto immaginasse – tanto che lì per lì non gli riuscì di imbastire una qualche frase laudativa che screditasse chi, per il solo fatto di saper leggere, si riteneva superiore agli altri.
Disse invece l’avvocato: «Il documento che ho l’onore di presentare e sottoporre all’attenzione di questo Eccellentissimo Giudice altro non è se non il contratto a suo tempo stipulato tra le parti oggi in causa: precisamente, si tratta di un contratto agrario cd. di «livello»; un contratto com’è noto, che vanta risalente tradizione, essendo stato istituito nel IV secolo d.C. dagli imperatori Valentiniano I e Flavio Giulio Valente, e che ha avuto larghissima diffusione fin dall’età di mezzo. Il contratto, com’è parimenti noto, deriva il suo nome dal fatto che il relativo testo veniva redatto in due esemplari, i “duo libelli pari tenore conscripti”: e cioè due libretti di uguale contenuto». «Conosco, conosco questo contratto – interloquì il giudice –. Mio padre è stato livellario del convento di Santa Maria de los Dolores de Camas per molti anni».
«Sapevo di poter contare su un giudice esperto – si intromise subito il procuratore –, e perciò non ho bisogno di chiarire come il contratto de qua, almeno nella sua versione più diffusa, ha durata ventennale, rinnovabile alla scadenza ma previo atto di ricognizione, da parte del livellario, del diritto eminente del concedente e a condizione di un esatto adempimento delle obbligazioni tutte che da esso nascano. Il livellario qui presente ha bensì effettuato le diverse migliorie puntualmente elencate nel presente contratto; non ha tuttavia reso a tempo debito l’atto di ricognizione né ha pagato le due ultime annualità di canone. A tenore pertanto di quanto sancito nel presente negozio nonché nei vigenti statuti comunali (e in particolare nell’Albarano), l’istante che ho l’onore di rappresentare in questa sede, e cioè don Venancio Feliciano Aloa y Gutierrez y Mendoza de la Veda, intende esercitare il diritto alla devoluzione del fondo: diritto, che comporta l’estinzione del diritto del concessionario, non avendo questi adempiuto alle sue obbligazioni». Tacque infine l’avvocato, cercando con gli occhi l’approvazione del suo patrono.
«Cos’avete da dire a vostra difesa?» chiese il giudice al menzionato livellario. Questi si batteva i pugni in testa e pareva sul punto di esplodere. Il frate che era con lui provò a calmarlo e, alla fine, l’uomo riuscì a dire: «Vero è quanto dice l’avvocato, ma ho mancato perché sono stato arruolato a forza nelle truppe che il Duca d’Alba stava ammassando per combattere la rivolta delle Fiandre. La guerra com’è noto è sempre in corso, ma sono stato congedato per le ferite riportate...». «Troppo facile invocare malattie e guerre come scusa – replicò l’avvocato –. Se bastasse ammalarsi per non rispettare i patti staremmo freschi. Ha detto bene il nostro Governatore quando, proprio ieri, ha sentenziato: “Caschi il mondo, bisogna stare ai patti. Se no, il mondo finirebbe a rotoli. Bisogna stare ai patti!”».
A questo punto il frate chiese esplicitamente il permesso di intervenire prendendo la parola: intento, che già aveva lasciato intendere durante l’arringa del procuratore, quando questi aveva lamentato il mancato pagamento del canone per far valere il brocardo ad impossibilia nemo tenetur. Se pure il servizio militare non esentava dal pagamento – disse il frate –, certo sospendeva la scadenza del debito, come ne sospendeva la prescrizione. E se certo il buon Sancho nulla poteva capire della massima latina, ben comprese l’avvocato che sul punto rischiava di uscirne sconfitto. Fu lesto perciò ad aggiungere: «Ad ogni buon conto il mio assistito, con la magnanimità che tutti gli riconoscono, è disposto a soprassedere al mancato pagamento del canone e rinuncia a chiederne conto. Invoca però la clausola che gli attribuisce il diritto insindacabile di ottenere la devoluzione del fondo». Tacque poi, come a dire: questo basta e avanza. Il contratto parla chiaro. Come può un giudice smentirsi da un giorno all’altro?
Il buon Sancho si sentiva in trappola: istintivamente sentiva ingiusta la pretesa dell’hidalgo, ma non sapeva come uscirne ed era quasi rassegnato a dargli ragione quando intervenne il frate, che rinunciò a far valere l’impossibilità di adempiere e cercò di salvare il salvabile. «Se anche fosse giusto spezzare un contratto che per tanti anni è stato regolarmente eseguito – disse – certo il livellario avrà diritto a indennità per le migliorie apportate, visto che il contratto viene a cessare...». «E il mio assistito, don Venancio Feliciano Aloa y Gutierrez y Mendoza de la Veda – replicò con sussiego l’avvocato – specchiato galantuomo qual è, certo non lo nega. Ed anzi, proprio in ragione di questo ha già provveduto a far valutare i miglioramenti apportati. Trascurati i minori, già compensati con la modestia del canone, restano gli altri, che consistono nella piantumazione di ulivi, per un totale di 48 piante. Antonio Floresta, nella sua qualità di “arrendatore”, e a tenore di quanto stabilito nel contratto, ha provveduto a stimare detti miglioramenti fissandone il valore in 2700 maravedì, poco meno di 80 reali».
«È un furto!» sbottò il contadino. «Badate a quel che dite o ve ne farò pentire – si adirò don Venancio –. Che Antonio Floresta debba far da arrendatore è scritto nero su bianco nel contratto». «Sarà – replicò il contadino –, ma faccio rispettosamente osservare che quest’uomo è l’appaltatore dei censi e delle gabelle: li riscuote da tutti i livellari per conto di don Venancio!». «Vero – replicò a sua volta l’arrendatore, fattosi avanti perché chiamato in causa – ma come mai non vi siete lamentato quando ho fissato il canone annuale in misura modesta? Vi ricordo che il primo anno avete pagato un moggio (e cioè uno staio) di orzo, il secondo un moggio e mezzo, il terzo due moggi, e così via (con un aumento di mezzo moggio di quanto pagato nell’anno precedente), in modo da tener conto dell’aumento di produttività man mano che venivano fatte le migliorie. Perciò, quel che bisogna pagarvi oggi sono soltanto gli ulivi». Anche il giudice era perplesso, ma non sapeva che dire: implacabile risuonava nella testa quel maledetto ritornello: “bisogna stare ai patti, bisogna stare ai patti...”.
A questo punto intervenne nuovamente il frate, rivolgendosi direttamente all’arrendatore: «Visto il sistema di conteggio del canone, che ne direste di pagare le piante allo stesso modo? Un reale per l’ultimo piantumato, uno e mezzo per il penultimo, due per il terz’ultimo, e così via, aumentando la cifra di mezzo reale man mano che si passa a piante più vecchie e magari già in produzione?». L’interpellato rimase incerto e guardò verso il padrone: non sapeva come l’avrebbe presa. Questi invece, ignorando l’avvocato che lo tirava per la giubba, fatto un rapido calcolo mentale, si dichiarò subito d’accordo. «Pur di chiudere la contesa e di dar ennesima prova della generosità che mi contraddistingue – disse – accetto questa proposta, che prendo come patto definitivo e irrevocabile. Sempre che – aggiunse – il nostro impareggiabile giudice lo consenta, visto che stiamo modificando patti già presi...».
Il buon Sancho avvertì l’ironia nelle parole dell’hidalgo, ma era fin troppo contento di cavarsi d’impaccio con un accordo tra le parti. «Farete dunque così – sentenziò, per far le viste di esser lui a dettar legge –. In un sacco metterete una fava per l’ultimo ulivo, una e mezza per il penultimo e così via. Contate poi le fave e tornate qui per la sentenza definitiva. L’udienza è sospesa per due ore».
Si allontanò quindi per andare a rinfrescare lombi con una visita alla ritirata e la bocca con un bacio prolungato a una damigiana di vino delle Asturie, dono del suo duca, mentre l’avvocato scuoteva il capo sconsolato.
* * *
Alla ripresa dell’udienza, don Venancio Feliciano Aloa y Gutierrez y Mendoza de la Veda presentava un volto pallidissimo e altero, il suo avvocato aveva sul viso una maschera di sufficienza – come a dire: peggio per te che non ti sei consultato –, il contadino era raggiante, il frate sorrideva sornione.
«Dunque – chiese il Governatore – quant’è venuto questo conteggio?». Rispose il frate: «L’abbiamo rifatto tre volte, con lo stesso risultato: 620 reali. Non uno di più, non uno di meno» soggiunse poi, parendogli troppo asciutto l’annuncio nudo e crudo del totale. Ma certo s’indovinava sul suo volto la soddisfazione della vittoria. «Ma è una somma spropositata – sbottò don Venancio – Tutto il fondo non vale questa somma». «Se sua Signoria si contenta – disse a questo punto il contadino – potremmo accordarci per l’affrancazione del fondo a mio favore al posto della somma che Ella mi deve»: il furbo contadino s’era fatto il conto che mai e poi mai sarebbe riuscito a ottenere il pagamento contro un signore di quella portata. L’hidalgo parve tentennare e il buon Sancho non rinunciò a prendersi una piccola rivincita: «Se l’illustre don Venancio acconsente ad apportare un altro strappo ai “patti definitivi e irrevocabili” già intercosi tra le parti – così si espresse, a dimostrazione del carattere vischioso del linguaggio curiale, che si attacca a tutti, colti e ignoranti – questa potrebbe essere una onorevole sistemazione della faccenda, con soddisfazione di entrambi e nessuna perdita da ambedue le parti».
Il contadino attendeva speranzoso, il pubblico ascoltava incuriosito, il buon Sancho se la rideva sotto i baffi. Infine, nonostante i rinnovati strattoni alla giubba da parte dell’avvocato, la vanità ebbe il sopravvento sull’avidità e don Venancio dichiarò solennemente al contadino: «Poiché tanto ci tieni a questo fondo, come ieri te l’ho conceduto in godimento temporaneo, oggi te lo concedo in proprietà perpetua». «E così sia, a gloria di nostro Signore Gesù Cristo» concluse il Governatore, rinviando all’indomani le altre cause pendenti.
Brano tratto da
“Chiedo giustizia, Eccellenza..." Resoconto esattissimo delle udienze di giustizia tenute da S.E. don Sancho Panza Governatore dell’isola di Baratteria