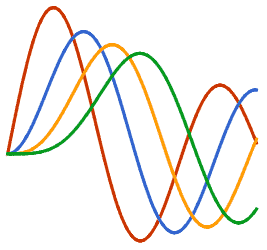- Baggio Simone - 15/09/2008
Cass. Civ. , sez. III, 15 settembre 2008, n. 23676, pres. Preden, rel. Travaglino - TRATTAMENTO MEDICO SU PAZIENTE INCAPACE DI CONSENTIRE, DIRITTO DI MORIRE E TESTAMENTO BIOLOGICO - Simone BAGGIO
2. Il trattamento medico eseguito su paziente incapace di esprimere il consenso.
Pare utile, preliminarmente, ricordare il principio, oramai consolidato nella giurisprudenza (almeno civile) della Cassazione, della autolegittimazione dell’attività medico-chirurgica, risultando la stessa di per sé legittima in quanto diretta alla tutela di un bene costituzionalmente garantito, attività cui il medico è abilitato dallo Stato. Ciò nonostante, l’attività medica non può svolgersi – fuori di alcuni casi eccezionali – senza o, a maggior ragione, contro il consenso del paziente. Il consenso del paziente, pur se necessario ai fini della valida esecuzione del trattamento sanitario, non si identifica con il consenso dell’avente diritto di cui all’art. 50 c.p., ma costituisce espressione del principio di autodeterminazione dell’individuo in relazione alla propria salute, principio che si evince dagli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione (v.: Cass. 25.11.1994, n. 10014, FI, 1995, I, 2917; Cass. 15.1.1997, n.364, FI, 1997, I, 771-781; Cass. 23.5.2001, n. 7027, DResp, 2001, 1165-1168).
Ciò premesso, se il consenso è requisito di liceità del trattamento medico-chirurgico, quid iuris per l’ipotesi in cui il paziente sia nella materiale impossibilità di esprimere efficacemente il proprio consenso al trattamento? Il problema può porsi anche nei termini seguenti: allorché il paziente sia nella impossibilità di prestare il proprio consenso, chi sono i soggetti cui spetta di prendere decisioni in luogo del paziente?
E’ il problema della cd. decisione surrogata.
E le soluzioni a tale quesito possono essere diverse: i familiari del paziente? Il pubblico ministero? Il medico stesso?
La natura del consenso (manifestazione del diritto, costituzionalmente garantito, all’autodeterminazione nelle scelte che attengono alla propria vita e alla propria salute, globalmente intesa) e i requisiti di validità dello stesso (in sintesi: personalità, libertà, spontaneità, attualità, revocabilità, specificità, forma) portano ad escludere che i familiari del paziente possano, nella vece del malato in stato di incoscienza, determinare, in un senso o nell’altro, l’esecuzione di un trattamento sanitario. Il consenso è espressione di un diritto personalissimo, il cui esercizio e la cui gestione non possono che spettare direttamente ed esclusivamente al soggetto della cui salute si tratti. Valgono poi, ad escludere ogni potere di ingerenza dei familiari, considerazioni di ordine pratico (quale, tra i prossimi congiunti, potrebbe ritenersi legittimato a decidere? In ipotesi di conflitto tra i famigliari, a quale volontà dovrebbe essere data attuazione? Non sempre, poi, i prossimi congiunti sono i migliori tutori della vita e della salute del paziente, potendo essere portatori di interessi configgenti con quelli del paziente).
La dottrina, salvo qualche isolata voce contraria, è concorde nell’escludere che i famigliari possano prestare il consenso al trattamento sanitario in luogo del paziente. In giurisprudenza, v.: Trib. Milano 14.5.1998, NGCC, 2000, 96-97; Ass. Firenze 18.10.1990, GP,1991, 187. La sentenza n. 23676/2008 richiama, nel corpo della motivazione, le decisione della Corte di Appello di Trieste n. 665/2003, emessa in data 18.7.2003 e depositata in data 25.10.2003 nella causa civile n. 288/02 R.G.. Tale decisione stabiliva che “nessun valore legale poteva, nella specie, essere attribuito alle informazioni fornite ai sanitari dai parenti del ”.
Allo stesso modo, e per le stesse ragioni ora esposte per i familiari del paziente, non sembra possa attribuirsi alcun potere decisionale al pubblico ministero. Al pubblico ministero il codice civile attribuisce il potere di attivare l’intervento del Giudice Tutelare nell’ipotesi in cui sorga conflitto di interessi tra il genitore ed il minore sottoposto alla sua potestà. E’ il caso che si verifica, ad esempio, allorché il minore abbisogni di un intervento sanitario urgente cui il genitore non acconsente, per motivi religiosi o altro. Laddove il rifiuto del genitore possa arrecare grave pregiudizio al minore troverà applicazione il rimedio previsto dall’art. 333 c.c.. Non diversamente è a dirsi per quanto riguarda la posizione dell’interdetto.
In dottrina si prospetta l’ampliamento dei margini di intervento del medico, il quale potrebbe procedere a trattamento medico su soggetto incapace di consentire nei limiti in cui si ravvisino le scriminanti o dello stato di necessità di cui all’art. 54 c.p., ovvero del consenso presunto (scriminante, questa, che sarebbe implicitamente prevista dall’art. 50 c.p.). La giurisprudenza esclude di regola che nell’ipotesi di paziente incapace di consentire si possa far riferimento al consenso presunto ed applica la scriminante dello stato di necessità (si vedano, sul punto: Cass. Civ., 30.7.2004, n. 14638; Cass. Civ., 15.11.1999, n.12621; Cass., 6.10.1997, n. 9705; Cass. 25.11.1994, n. 10014). Tale scriminante, per essere operante, pone i seguenti requisiti: a) il pericolo attuale di grave danno alla persona; b) che il pericolo non sia stato volontariamente causato dall’agente; c) la non evitabilità del danno se non attraverso il compimento dell’azione di reato; d) la proporzione tra offesa minacciata e arrecata. I requisiti sopra individuati, peraltro, possono rendere problematica l’applicazione della scriminante: a) il pericolo deve essere attuale, sicché non rilevano le situazioni a pericolo solo futuro; b) il pericolo non deve essere evitabile con altro mezzo, per cui occorre la certezza che la prestazione medica prescelta rappresenti l’unica via per scongiurare il danno alla salute del paziente; c) il pericolo non deve, inoltre, essere stato volontariamente causato, sicché non rientrerebbero nell’ambito della scriminante tutti i casi in cui l’intervento del sanitario avesse concorso anche solo ad aggravare le condizioni del paziente. E – si noti – la giurisprudenza pare costante nell’applicare rigorosamente i limiti dettati dall’art. 54 c.p..
Si veda:
«In tema di stato di necessità, la situazione di pericolo, quando si riconnette all'alimentazione, alle cure mediche, ai medicinali, ecc. deve avere un carattere di indilazionabilità e cogenza tali da non lasciare all'agente alternativa diversa dalla violazione della legge; ciò perché la moderna organizzazione sociale, venendo incontro, con i mezzi più disparati a coloro che possono trovarsi in pericolo di vita, per il non soddisfacimento dei predetti bisogni, ha modo di evitare il possibile, irreparabile danno alla persona»
(Cass. pen., 11.11.1986; Caporin, Cass. pen., 1988, 870).
Ancora:
«L'esimente dello stato di necessità richiede che la situazione di pericolo (ancorché relativo all'alimentazione, alle cure mediche, etc.) abbia un tale carattere di indilazionabilità e cogenza da non lasciare all'agente altra alternativa che quella di violare la legge»
(Cass. pen., 6.7.1982, Canini, Cass. pen. 1984, 84).
Anche Cass. n. 23676/2008 giustifica l’operato dei medici intervenuti sul paziente a mezzo di trasfusioni di sangue facendo ricorso alla scriminante dello stato di necessità:
“E’ convincimento del collegio, in sintonia con quanto in proposito opinato dalla corte territoriale, che, nell’ipotesi di pericolo grave ed immediato per la vita del paziente, il dissenso del medesimo debba essere oggetto di manifestazione espressa, inequivoca, attuale, informata” (pagg. 11-12).
Ed in altri punti della motivazione:
“…l’informazione avente ad oggetto la rappresentazione di un pericolo di vita imminente e non altrimenti evitabile…” (pag. 12);
“…a fronte dell’improvviso, repentino, non altrimenti evitabile insorgere di un reale pericolo di vita, scongiurabile soltanto con una trasfusione di sangue” (pag.13).
Pare utile concludere su tale questione richiamando il concetto di cd. necessità medica. Il concetto di necessità medica (elaborato da Vassalli), in contrapposizione al ben più limitato stato di necessità di cui all’art. 54 c.p., è così riassumibile: da un lato è ravvisabile la cd. necessità medica urgente legata ad un pericolo attuale per la salute - nel senso del suo aggravamento altamente probabile in carenza di cure tempestive - o addirittura per la vita; dall’altro lato, è ravvisabile la cd. necessità medica non assolutamente urgente con teorica differibilità del trattamento, ma con rischi non esattamente calcolabili circa l’evoluzione possibile o probabile della malattia, tali da richiedere comunque ulteriori prestazioni rispetto a quella in corso, in precedenza concordata con il paziente. Lo stato di “necessità medica” comprenderebbe dunque sia le ipotesi di rischio grave ed attuale per la salute del paziente, che rientrano sicuramente nel campo di applicazione dell’art. 54 c.p., sia le ipotesi in cui, pur non sussistendo indifferibile urgenza, vi sarebbe comunque l’opportunità di non rinviare il trattamento medico nell’interesse del paziente, tenuto conto che in medicina è spesso necessario agire anticipatamente per impedire l’aggravamento delle potenzialità lesive insite in una determinata situazione patologica.
La “necessità medica” è stata criticata in dottrina, soprattutto in considerazione della assenza di base normativa, pur essendosi affermato nel contempo la sua validità in una prospettiva de iure condendo. Si rileva, peraltro, come in dottrina sia stata proposta una interpretazione più ampia dell’art. 54 c.p., interpretazione che consentirebbe, sostanzialmente, di attribuire base normativa alla c.d. necessità medica. Si è infatti proposto di interpretare il requisito della attualità del pericolo non esclusivamente in base ad un criterio temporale, basato sulla “imminenza cronologica” del danno, bensì avendo riguardo alla “probabilità” del suo verificarsi. In tali casi, dunque, sarebbe opportuno agire anticipatamente, laddove l’attesa potesse comportare come conseguenza la inevitabilità o l’aggravamento del danno. Se accolta, tale interpretazione, consentirebbe di ampliare notevolmente la sfera di azione del medico.
La cd. necessità medica potrebbe assumere base normativa in forza della convenzione di Oviedo, la quale – richiamata anche dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 23676/2008 – all’articolo 8 stabilisce che “Allorquando in ragione di una situazione d’urgenza, il consenso appropriato non può essere ottenuto, si potrà procedere immediatamente a qualsiasi intervento medico indispensabile per il beneficio della salute della persona interessata». La norma pare avere una portata decisamente ampia, che va al di là dello stato di necessità sancito dall’art. 54 c.p.. “Urgenza” ed “indispensabilità” del trattamento medico non si identificano con la “non dilazionabilità” dell’intervento richiesta dall’art. 54 c.p., con la situazione di “emergenza”, ma paiono comprendere nel loro alveo anche tutte le ipotesi in cui vi sarebbe comunque l’opportunità di non rinviare il trattamento medico nell’interesse del paziente, anche in considerazione della frequente necessità di agire anticipatamente per impedire l’aggravamento delle potenzialità lesive insite in una determinata situazione patologica. Si rileva, altresì, come, ai sensi della norma in parola, il medico sia legittimato ad eseguire “qualsiasi” intervento purché indispensabile non al fine di evitare un grave danno alla persona (come richiesto dall’art. 54 c.p.), quanto invece per il beneficio della salute della persona interessata. Sembra, dunque, che la disposizione normativa individui il fondamento di liceità del trattamento medico nelle ipotesi di incapacità del paziente di consentire in quella che si è sopra definita “necessità medica”. Tale causa di giustificazione, criticata in dottrina per l’assenza di base normativa, pare oggi trovare un ancoraggio forte nella norma di origine sovranazionale.
3. Dissenso alle cure e diritto di morire.
Il problema del dissenso del paziente alle cure può essere posto nei termini seguenti: può il medico intervenire nei confronti di paziente allorché questi, in presenza di situazione di pericolo grave per l’integrità fisica o per la vita stessa, rifiuti il trattamento sanitario?
Diffusamente, in dottrina, vi è chi ritiene che il medico debba intervenire, anche contro la volontà del paziente, allorché sia in gioco la vita o l’integrità fisica del malato. L’art. 2 della Costituzione riconosce i diritti inviolabili dell’uomo, ma richiede altresì l’osservanza dei doveri inderogabili. Ogni persona avrebbe verso sé stessa il dovere di realizzare il suo pieno sviluppo e di rispettare e conservare la sua integrità fisica. L’art. 32 della Costituzione, poi, tutela la salute, oltre che come fondamentale diritto dell'individuo, anche nell'interesse della collettività, dal che deriverebbe un dovere di autotutela della propria integrità fisica e personale. Il rispetto e la conservazione della propria integrità fisica si pongono quindi come limiti del diritto che ciascuno ha in relazione alla disposizione del proprio corpo. Gli stessi limiti vengono assegnati agli atti di disposizione negativi (rifiuto di cure mediche che incidano sull'integrità) che potrebbero condurre ai medesimi effetti scongiurati dall’art. 5 c.c.. La vita e l’integrità fisica – si afferma ancora – sono beni tutelati dall’ordinamento in modo assoluto, come si evince dagli articoli 579 e 580 c.p., 5 c.c. e, prima ancora, dall’art. 2 della Costituzione. Laddove il dissenso al trattamento medico si sostanzi, per le conseguenze da esso derivanti, in un atto di disposizione della vita o della integrità fisica, esso non potrebbe ritenersi vincolante per il medico, il quale avrebbe il dovere di intervenire in modo del tutto lecito.
Si rileva, ulteriormente, come l’intervento del medico, pur in presenza di espresso dissenso del paziente, potrebbe in ogni caso trovare giustificazione nello stato di necessità. Invero, un intervento del medico non consentito, ed anzi rifiutato – allorché sussista grave ed attuale pericolo per la salute del paziente (effettivo rischio di morire o anche di subire una grave compromissione del bene della integrità fisica), non altrimenti evitabile se non attraverso idoneo trattamento sanitario – non potrebbe essere punito, sussistendo nel caso gli estremi dello stato di necessità di cui all’art. 54 c.p..
Tale tesi trova conferma in alcune pronunce della Corte di Cassazione Penale:
“Diversamente influisce il dissenso del paziente la cui volontà, nel senso della sua libera autodeterminazione, ha trovato un rafforzamento a livello costituzionale (art. 32): a fronte di una manifestazione di volontà esplicitamente contraria all'intervento terapeutico il pericolo grave ed attuale per la vita o per la salute del paziente configura lo stato di necessità”
(Cass. pen., 9.3.2001, Barese, Riv. Pen., 2001, 806).
Ancora:
«è indubbio che l'agire del chirurgo sulla persona del paziente contro la volontà di costui, salvo l'imminente pericolo di morte o di danno sicuramente irreparabile ad esso vicino, non altrimenti superabile, esita in una condotta illecita capace di configurare più fattispecie di reato, quali violenza privata (art. 610 c.p., la violenza essendo insita nella violazione della contraria volontà), lesione personale dolosa (art. 582 c.p.) e, nel caso di morte, omicidio preterintenzionale (art. 584 c.p.)»
(Cass. pen., 27.3.2001, Cicarelli, Riv. Pen., 2002, 364).
La dottrina prevalente è tuttavia orientata in senso difforme.
Il consenso è espressione del principio di autodeterminazione dell’individuo in relazione alla propria salute, principio che si evince dagli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione. Il diritto incoercibile all’autodeterminazione della persona nelle scelte fondamentali che attengono alla propria vita e, in special modo, alla propria salute, nonché il divieto di trattamenti sanitari obbligatori che non siano imposti anche per esigenze superiori a quelle del singolo individuo conducono ineluttabilmente alla affermazione che nessun intervento medico può essere compiuto contro la volontà del paziente, anche nell’ipotesi in cui dalla mancata esecuzione della prestazione di cura possa derivare la morte del paziente stesso. Come è stato efficacemente affermato, del tutto pleonastica sarebbe l’affermazione del principio del consenso se poi si negasse valore al dissenso e si permettesse al medico di intervenire nonostante il rifiuto del paziente. Dovrebbe così riconoscersi sussistente nel nostro ordinamento il c.d. diritto di morire.
“Disponibilità del diritto (anche negativo) alla salute vuol dire perciò anche diritto di morire, diritto quindi a «lasciarsi morire», ma anche al suicidio, diritto ad ottenere l’eutanasia ”
(Barile).
Invero, pare utile distinguere nettamente il rifiuto di cure, l’eutanasia e il suicidio.
Una cosa è il rifiuto delle cure pur fino alle estreme conseguenze; un’altra è il suicidio. Invero, nel suicidio, la causa della morte deriva dal comportamento illecito del medesimo soggetto che la provoca; nel rifiuto di cure, la causa è naturale e il soggetto, libero di decidere, sceglie di non curarsi e di far sì che la natura segua il suo corso.
Altra cosa ancora è l’eutanasia, che integra gli estremi di reato.
L’omissione di cure, rispetto al suicidio e all’eutanasia, costituisce comportamento consentito dall’ordinamento in forza del rispetto dovuto alla libertà di autodeterminazione del soggetto. Il diritto del paziente al rispetto della propria volontà non contrasta con i doveri del medico. Per quanto necessiti, si ricorda come il codice di deontologia medica stabilisce espressamente che in presenza di documentato rifiuto di persona capace di intendere e di volere, il medico deve desistere dai conseguenti atti diagnostici e/o curativi, non essendo consentito alcun trattamento medico contro la volontà della persona (art. 32, 4° co., Codice di Deontologia medica).
Nella giurisprudenza si afferma l’illiceità del comportamento del medico che intervenga in presenza di rifiuto del paziente:
“In tema di attività medico - chirurgica (in mancanza di attuazione della delega di cui all'art. 3 l. 28 marzo 2001 n. 145, con la quale è stata ratificata la convenzione di Oviedo del 4 aprile 1997 sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina), deve ritenersi che il medico sia sempre legittimato ad effettuare il trattamento terapeutico giudicato necessario per la salvaguardia della salute del paziente affidato alle sue cure, anche in mancanza di esplicito consenso, dovendosi invece ritenere insuperabile l'espresso, libero e consapevole rifiuto eventualmente manifestato dal medesimo paziente, ancorché l'omissione dell'intervento possa cagionare il pericolo di un aggravamento dello stato di salute dell'infermo e persino, la sua morte; in tale ultima ipotesi, qualora il medico effettui ugualmente il trattamento rifiutato potrà profilarsi a suo carico il reato di violenza privata ma non - nel caso in cui il trattamento comporti lesioni chirurgiche ed il paziente muoia - il diverso e più grave reato di omicidio preterintenzionale, non potendosi ritenere che le lesioni chirurgiche, strumentali all'intervento terapeutico, possano rientrare nella previsione di cui all'art. 582 c.p.”
(Cass. pen., 11.7.2002, Ragiusan, 2003, f. 229-0, 525 s.m.)
In precedenza, nello stesso senso, si veda la nota sentenza della Corte di Assise di Firenze (Ass. Firenze, 18.10.1990, GP, II, 1991, 186),
Anche Cassazione n. 23676/2008 si riafferma con decisione i principi ora enunciati. Si legge in tale sentenza:
“Va in premessa osservato come il collegio non intenda punto negare il più generale principio (di indubbia rilevanza costituzionale, che emerge, tra l’altro, tanto dal codice di deontologia medica quanto dal documento 20.6.1992 del comitato nazionale per la bioetica) in forza del quale va riconosciuto al paziente un vero e proprio diritto di non curarsi, anche se tale condotta lo esponga al rischio stesso della vita” (pag. 10).
Prosegue la menzionata sentenza, entrando nello specifico della questione relativa alle trasfusioni di sangue rifiutate dai testimoni di Geova per motivi di credo religioso:
“Né pare seriamente contestabile quanto sostenuto da un’attenta dottrina in tema di consenso informato nella trasfusione di sangue, e cioè che, in subiecta materia, deve ritenersi diversa, rispetto ai casi ordinari, la fattispecie in cui sia il testimone di Geova, maggiorenne e pienamente capace, a negare il consenso alla terapia trasfusionale, essendo in tal caso il medico obbligato alla desistenza da qualsiasi atto diagnostico e terapeutico. E ciò perché il conflitto tra due beni – entrambi costituzionalmente tutelati – della salute e della libertà di coscienza non può essere risolto sic et simpliciter a favore del primo, sicchè ogni ipotesi di emotrasfusione obbligatoria diverrebbe per ciò solo illegittima perché in violazione delle norme costituzionali sulla libertà di coscienza e della incoercibilità dei trattamenti sanitari individuali (così, un rifiuto “autentico” della emotrasfuzione da parte del testimone di Geova capace – avendo, in base al principio personalistico, ogni individuo il diritto di scegliere tra salvezza del corpo e salvezza dell’anima – esclude che qualsiasi autorità statuale - legislativa, amministrativa, giudiziaria – possa imporre tale trattamento: il medico deve fermarsi)” (pagg. 10-11).
Anche il rifiuto, peraltro, deve essere caratterizzato dagli stessi requisiti richiesti per il consenso. In particolare, il rifiuto al trattamento medico, come e ancor più del consenso, deve essere consapevole. Il dissenso, infatti, stante le conseguenze che da esso possono derivare in termini di pregiudizio per la salute, deve essere espresso da soggetto il quale abbia piena conoscenza sia dell’intervento sanitario rifiutato sia dello sviluppo, certo o probabile, della malattia non curata. Fondamentale allora si rileva l’informazione.
Ma qui si entra nell’ultima questione posta all’inizio del presente articolo, ossia la validità della volontà espressa dal paziente “ora per allora”.
4. Rifiuto delle cure e testamento biologico.
Qual è il valore da attribuire alla volontà del paziente espressa in un momento antecedente alla perdita di coscienza?
La volontà del paziente, espressione del principio costituzionalmente garantito alla autodeterminazione, è sovrana e deve essere rispettata. Peraltro devono essere distinte due ipotesi fra loro non assimilabili: a) da un lato, vengono in evidenza i casi in cui lo stato di incoscienza sia stato previsto o, addirittura, programmato dal paziente (ad esempio: lo stato di incoscienza può costituire il naturale approdo di una malattia; il paziente si sottopone ad intervento chirurgico in anestesia totale, così pianificando il proprio stato di incapacità); b) dall’altro lato, vengono in evidenza quelle ipotesi in cui lo stato di incapacità sia stato preso in considerazione dal paziente esclusivamente in termini possibilistici, una possibilità futura che poi di fatto si verifica. Le due ipotesi differiscono notevolmente: a) nel primo caso il paziente prende la propria decisione in relazione ad una ipotesi reale, imminente e comunque pressoché certa; b) nel secondo caso, invece, il soggetto manifesta la propria volontà in relazione ad un evento futuro e incerto, senza avere conoscenza di tutte le condizioni che potrebbero sussistere al momento del verificarsi dell’ipotesi considerata. Esemplificando (viene in aiuto la sentenza in commento): una ipotesi è quella del testimone di Geova che, prima di sottoporsi ad un intervento chirurgico programmato, manifesti il rifiuto ad emotrasfusioni; altra e diversa ipotesi, invece, è quella del testimone di Geova che sottoscriva una dichiarazione da valersi per l’ipotesi, non prevista e anzi scongiurata, di un futuro ed incerto intervento chirurgico.
La prima fattispecie è stata presa in considerazione nel paragrafo precedente.
La seconda fattispecie pone il problema del cd. testamento biologico.
Testamento biologico (o testamento di vita) costituisce atto di manifestazione di volontà a mezzo della quale il soggetto, in relazione ad una futura e solo ipotetica situazione, esprime la propria autodeterminazione in relazione a trattamenti sanitari (nonché in relazione all’uso del proprio corpo, alla sepoltura e ai funerali). Manca, ad oggi (anche se è allo studio del Parlamento), una legge che disciplini il testamento biologico.
Il consenso del paziente (così come il dissenso del medesimo), per essere validamente espresso, deve essere personale, libero, spontaneo, attuale, revocabile, specifico ed informato. Il testamento biologico pone, in particolare, il problema della attualità e della informazione del consenso/dissenso al trattamento medico. La volontà del paziente che non sia attuale – e quindi che non abbia attinenza con la fattispecie concreta e con lo specifico intervento medico richiesto – non può considerarsi valida autorizzazione. Ed invero, manca nel soggetto la consapevolezza della malattia, della sua prevedibile evoluzione, delle possibilità terapeutiche alternative esistenti. Il consenso (ovvero il dissenso) non sarebbe informato e non potrebbe essere fondato su una rappresentazione veritiera della realtà. In concreto: un conto è il rifiuto di un determinato trattamento sanitario espresso allorché il paziente si trovi in una condizione di piena salute; altra cosa è la riaffermazione del medesimo dissenso allorché il mancato intervento terapeutico comporti il rischio di morte del paziente. Va tenuto presente poi che non solo la malattia (e, dunque, il “nemico” da debellare) non sarebbe conosciuta; ma anche le condizioni personali del soggetto-paziente potrebbero col tempo mutare, sia fisicamente – così rendendo, ad esempio, non più consigliabile un dato trattamento terapeutico – sia psicologicamente – potendo, ad esempio, cambiare le convinzioni religiose, la preferenza del soggetto per determinati trattamenti sanitari rispetto ad altri, le aspettative del soggetto, ecc. –. In altri termini, la situazione in cui si viene a trovare il soggetto nel momento in cui redige il proprio “testamento biologico” può essere radicalmente diversa da quella sussistente nel momento in cui il medesimo abbisogna dell’intervento medico.
Su tale aspetto, che costituisce sicuramente il punto centrale della sentenza in commento, la Suprema Corte si è pronunciata coerentemente con le argomentazioni della dottrina:
“E’ convincimento del collegio, in sintonia con quanto in proposito opinato dalla corte territoriale, che, nell’ipotesi di pericolo grave ed immediato per la vita del paziente, il dissenso del medesimo debba essere oggetto di manifestazione espressa, inequivoca, attuale, informata.
Esso deve, cioè, esprimere una volontà non astrattamente ipotetica ma concretamente accertata; un’intenzione non meramente programmatica ma affatto specifica; una cognizione dei fatti non soltanto “ideologica”, ma frutto di informazioni specifiche in ordine alla propria situazione sanitaria; un giudizio e non una “precomprensione”: in definitiva, un dissenso che segua e non preceda l’informazione avente ad oggetto la rappresentazione di un pericolo di vita imminente e non altrimenti evitabile, un dissenso che suoni attuale e non preventivo, un rifiuto ex post e non ex ante, in mancanza di qualsivoglia consapevolezza della gravità attuale delle proprie condizioni ” (pagg. 11-12).
Altro passaggio di estrema rilevanza:
“…come la validità di un consenso preventivo ad un trattamento sanitario non appare in alcun modo legittimamente predicabile in assenza della doverosa, completa, analitica informazione sul trattamento stesso, così la efficacia di uno speculare dissenso ex ante, privo di qualsiasi informazione medico-terapeutica, deve ritenersi altrettanto impredicabile, sia in astratto che in concreto, qualora il paziente, in stato di incoscienza, non sia in condizioni di manifestarlo scientemente, e ciò perché altra è l’espressione di un generico dissenso ad un trattamento in condizioni di piena salute, altro è riaffermarlo puntualmente in una situazione di pericolo di vita” (pag. 13).
La volontà del paziente rimane dunque totalmente sfornita di rilievo? Non è così, in quanto la volontà del soggetto assume comunque rilievo, seppur minimo.
Si è affermato in dottrina:
“Questa volontà, comunque, costituisce un’espressione di libertà costituzionali, come quella di manifestare il proprio pensiero (art.21) o di professare la propria fede religiosa (art.19), alla quale può essere attribuito valore, anche se su un piano diverso. Va considerato infatti che, in casi del genere, la decisione finisce con l’essere essenzialmente medica. Nel corso delle operazioni che portano al giudizio di appropriatezza di un trattamento, il medico, nel valutare la concreta situazione del paziente, non può non tener conto tra l’altro della volontà prima espressa, anche se in forma ipotetica.
In altri termini, il medico ben può, e forse deve, far rientrare la volontà prima espressa dal paziente, anche se in forma ipotetica, tra i criteri utili per valutare se quel trattamento è il più adatto in quella specifica situazione per quel paziente, con la sua storia, le sue convinzioni, la sua sensibilità.
Entro questi limiti può valere la volontà espressa nel will e anche la volontà espressa da un procuratore, che sia indicato in un living will, come la persona in grado di prendere decisioni sulle cure. Allo stato della legislazione la volontà di questa persona può avere il valore di una testimonianza sulle convinzioni manifestate in passato dal paziente, ma non può essere considerata come la volontà di un soggetto che ha il potere di decidere”
(Santosuosso).
La volontà del paziente – non attuale – viene così ad essere “attualizzata”.
La convenzione di Oviedo dedica l’art. 9 ai desideri precedentemente espressi dal paziente:
«I desideri precedentemente espressi a proposito di un intervento medico da parte di un paziente che, al momento dell’intervento, non è in grado di esprimere la sua volontà saranno tenuti in considerazione»
(art.9, Convenzione di Oviedo).
Tale norma – si afferma – non attribuisce il valore di precetti vincolanti alla volontà espressa dal paziente, ma esclusivamente quello di semplici desideri che il medico è tenuto a prendere in considerazione. E’ lo stesso rapporto esplicativo della Convenzione a fornire tale indicazione:
«L'articolo prevede che quando la persona ha così fatto conoscere in anticipo i propri desideri, questi devono essere presi in considerazione. Tuttavia la presa in considerazione dei desiderata precedentemente espressi non significa che questi dovranno necessariamente essere seguiti. Così, per esempio, quando questi desiderata sono stati espressi molto tempo prima dell'intervento e le condizioni scientifiche hanno fatto molti progressi, può essere giustificato non seguire l'opinione del paziente. Il medico deve, dunque, nella misura del possibile, assicurarsi che i desiderata del paziente si adattino alla situazione presente e siano sempre validi tenuto conto specialmente del progresso delle tecniche mediche»
(art. 62, Rapporto esplicativo della Convenzione di Oviedo).
In modo conforme si esprime il codice di deontologia medica, secondo cui il medico, se il paziente non è in grado di esprimere la propria volontà in caso di grave pericolo di vita, non può non tenere conto di quanto precedentemente manifestato dallo stesso (art. 34, 2° co., Codice di deontologia medica).
Cosa dice sul punto la Corte di Cassazione?
La decisione della Corte di Cassazione in commento sembra attribuire maggiore rilevanza alla volontà precedentemente espressa dal paziente rispetto a quella di semplice indirizzo per l’attività del medico. Si legge nella motivazione:
“…non si vuole, peraltro, sostenere che, in tutti i casi in cui il paziente portatore di forti convinzioni etico-religiose (com’è appunto il caso dei testimoni di Geova) si trovi in stato di incoscienza, debba per ciò solo subire un trattamento terapeutico contrario alla sua fede. Ma è innegabile, in tal caso, l’esigenza che, a manifestare il dissenso al trattamento trasfusionale, sia o lo stesso paziente che rechi con sé una articolata, puntuale, espressa dichiarazione dalla quale inequivocabilmente emerga la volontà di impedire la trasfusione anche in ipotesi di pericolo di vita, ovvero un diverso soggetto da lui stesso indicato quale rappresentante ad acta il quale, dimostrata l’esistenza del proprio potere rappresentativo in parte qua, confermi tale dissenso all’esito della ricevuta informazione da parte dei sanitari” (pagg. 13-14).
Ebbene, se ben si comprende il pensiero manifestato dalla Corte di Cassazione, sembra che anche una dichiarazione espressa in un momento antecedente e diverso rispetto a quello in cui si viene a concretizzare il pericolo per la salute del paziente possa avere l’efficacia di impedire un determinato intervento sanitario. Ciò, a condizione che tale dichiarazione sia “articolata, puntuale, espressa” e che da essa emerga inequivocabilmente la volontà di impedire un determinato trattamento sanitario “anche in ipotesi di pericolo di vita”.
Sulla scorta di tali argomentazioni la Corte afferma l’insufficienza nel caso di specie del cartellino con la scritta niente sangue che il paziente portava con sè al fine di impedire l’intervento medico di emotrasfusioni. Invero, si legge,
“se l’affermazione ha una sua logica e una sua coerenza con riferimento al possibile stato di incoscienza del ricoverato, essa non consente l’ulteriore inferenza che conduca a presumerne una sorta di implicita efficacia tout court, estesa, cioè, anche all’ipotesi del concreto pericolo di vita che il paziente stesso si troverebbe a correre in assenza di trasfusione, mentre è proprio con riferimento a questa specifica evenienza che – va ripetuto – il (non) consenso deve manifestarsi nella sua più ampia, espressa, consapevole, inequivoca forma” (pag. 14).